| La famiglia Rugo. Un dramma lungo un secolo Dal libro “Gli italiani sulle rive del Bajkal” di Elvira Kamenshchikova | 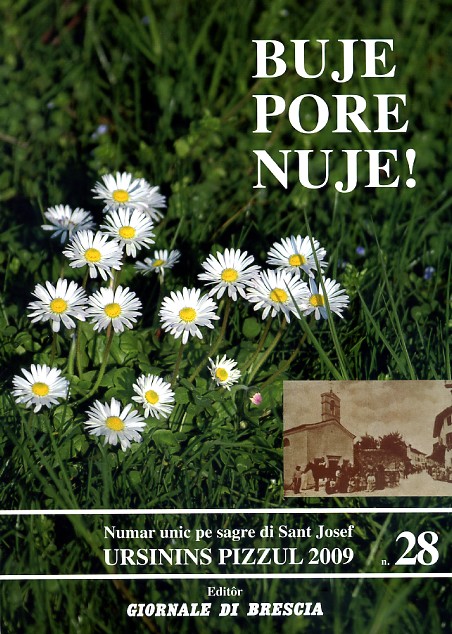 |
| La famiglia Rugo. Un dramma lungo un secolo Dal libro “Gli italiani sulle rive del Bajkal” di Elvira Kamenshchikova | 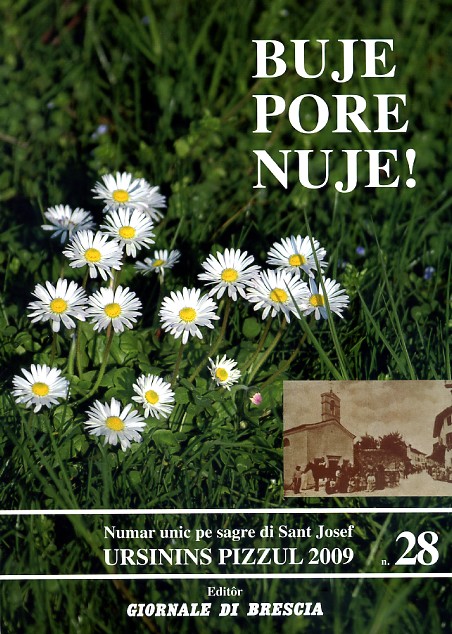 |
| Nella provincia di Udine, gli uomini da anni abbandonavano i poveri paesi della pedemontana per andare a lavorare come spaccapietre, muratori, scalpellini. L’esodo iniziò verso la fine del XIX secolo e continuò fino agli anni 20 del XX. Da principio si diressero verso le città europee, da dove, alla fine della stagione, facevano rientro a casa, in seguito cominciarono ad emigrare verso l’America, dove rimanevano per anni senza far ritorno. Quando si diffuse la notizia della costruzione della Transiberiana, si ebbe una partenza in massa alla volta della Russia, un Paese sconosciuto, dove si sarebbero fermati decine di anni, a volte anche per sempre. Da Campone partirono Sante e Felice Rugo. Nel 1903 lavorarono alla costruzione della galleria del Gran Khingan e poi, dopo il Bajkal, alla stazione di Mogson. Le tracce di Felice, però, ben presto si persero, nessuno dei parenti ebbe più sue notizie. Sante Rugo, nato a Campone di Sopra nel 1880, arrivò in Russia che aveva appena 20 anni. Il suo destino era segnato: doveva rimanere in questa terra fino alla fine dei suoi giorni. Nel 1906 sposò la polacca Valeria Noniscevskai, il matrimonio si celebrò a Mogson. Nel 1907 ebbero una figlia, Eugenia, in seguito nacque Amanda. Dopo la nascita della figlia, la famiglia Rugo si spostò a Irkutsk, dove vivevano molti friulani ed anche polacchi. Nel 1912 Valeria morì, lasciando il marito con le bambine piccole. Poiché, a causa del suo mestiere di muratore Sante era costretto a spostarsi continuamente, affidò le figlie ad una famiglia polacca. Nel 1913 passò a nuove nozze con la russa Caterina Gurova, alla quale, però, nascose l’esistenza delle sue bambine. Probabilmente si comportò così per paura che la giovane non volesse sposare un vedovo con figli. Anche se era di bell’aspetto e con i baffi. Durante questo periodo sparì misteriosamente Eugenia. Probabilmente, quando la famiglia a cui era stata affidata decise di rientrare in Polonia, la portò con sé. Sante, avvertito della loro partenza, arrivò tardi al treno per riprendersi la figlia. Forse oggi, in Polonia, vivono discendenti di Sante Rugo e di Valeria Noniscevskai. In seguito Sante confessò a Caterina di avere una figlia e la riportò in famiglia. Nel 1914, da Caterina e Sante nacque Rodolfo e nel 1920 Dante. Poiché non c’era lavoro sulla Transbaicalica, Sante divenne operatore e guardiano presso il cinema “Giganti”, che apparteneva ad Antonio Donatella. La famiglia Rugo viveva in una piccola casa, nel cortile del cinema. In una fotografia scattata da Giovanni Minisini (bujese) nel 1923, si vedono sette uomini molto belli, nel pieno delle loro forze, ricchi di speranza nel futuro. La Rivoluzione e la guerra civile costrinsero molti a partire in fretta ed a rientrare in patria. Chi lavorava nella parte ovest del Paese, raggiunse la frontiera via terra, chi invece si trovava a est si imbarcò a Kharbin, Shanghai, Vladivostok. Amanda, all’inizio degli anni 30, viveva da sola, si sposò nel 1932. Ebbe un figlio, Edoardo e nell’aprile 1937 Albina. Il nonno Sante non vide mai la nipotina, infatti, gravemente malato, morì nel 1936. Dall’ospedale scrisse alla sua amata Amanda, che chiamava “bella”, “meravigliosa”. “Ciao cara, bella, ti informo che non sto molto bene, e non so come finirà, forse in estate guarirò, ma i dottori mi danno poca speranza. Speriamo che l’arrivo della primavera porti qualche cambiamento in meglio.......... . Resto tuo padre”. In calce alla lettera Amanda scrisse: “Ultima lettera di mio padre prima di morire”. Il nipote ed il pronipote di Amanda dicono che era molto buona e tranquilla. In lei non c’era niente del caldo temperamento italiano: il sangue nordico di sua madre Valeria, che era polacca, si era mescolato con caldo sangue del Sud del padre. Nel novembre del 1937 partirono dalla Siberia tutti coloro che furono espulsi e costretti a rientrare in una patria che non avevano mai visto. Non vennero accolte, né prese in considerazione, le suppliche accompagnate da lacrime, né le numerosissime richieste scritte. La famiglia Rugo si rivolse a tutte le Autorità fino al momento della partenza, chiedeva di poter rimanere in Unione Sovietica, perché tutti i figli erano nati a Irkutsk, non conoscevano la lingua italiana, in Italia non c’era più nessun parente di Sante Rugo e, anche se ce ne fossero stati, non avevano loro notizie. Non ottennero mai alcuna risposta alle loro richieste. E questa, probabilmente, fu la loro fortuna. In altre famiglie la vita si trasformò in tragedia. Negli stessi giorni di novembre del 1937, alla stazione di Cita, località che si trova 1000 km ad est di Irkutsk, si verificavano le stesse scene che si potevano vedere a Irkutsk, come capitò alla famiglia Lenarduzzi che venne divisa. La Gurova aveva passaporto italiano, come Amanda. Furono così tutti costretti a rientrare in Italia: Caterina, Rodolfo, Dante, Amanda con Edoardo di 5 anni ed Albina di 7 mesi. Partirono verso l’ignoto, l’Italia non era la loro patria. I figli, oggi non ricordano niente di questo periodo, dagli adulti, però, hanno saputo quante lacrime sono state versate alla stazione di Irkutsk a causa di queste partenze forzate. Una donna che non voleva partire, venne spinta a forza sul treno, mentre il marito, che era militare, fu costretto a rimanere. A Cita fu separata la famiglia di Emma Lenarduzzi: lei, la madre e la figlia, vennero rimpatriate, mentre il marito russo dovette restare. La famiglia Rugo fece un lungo viaggio, verso la patria sconosciuta: Mosca-Budapest-Vienna-Roma e poi lo sperduto paese di Campone, un pugno di case sul pendio della montagna. Qui venne loro offerto un piccolo alloggio e del cibo. La vita era resa difficile, non solo per i molti disagi, ma soprattutto perché nessuno di loro conosceva l’italiano. Le due donne avevano capito che non sarebbero riuscite ad allevare i figli in quel piccolo paese posto alla fine del mondo, per questo nel 1940 si trasferirono Roma. Iniziarono a lavorare come cameriere in un albergo, vivevano in un appartamento preso in affitto vicino a “Fontana di Trevi”. In seguito Amanda fece la domestica presso una famiglia. La padrona aveva una sorella che era Direttrice in un collegio dove studiavano ragazze straniere: francesi, tedesche, austriache. Albina venne messa in questo collegio quando aveva 3 anni. La sua educatrice era russa e lei la ricorda ancora con affetto. Anche Edoardo venne messo in un collegio per bambini rientrati dall’estero, dove veniva impartita un’educazione legata all’ideologia fascista. Edoardo ricorda questi anni come un periodo difficile, in cui si pativa la fame, alla sera si mangiavano solo cipolle lesse. In seguito venne a sapere che gli amministratori rubavano, per comperarsi gioielli, automobili, titoli nobiliari, cosa che allora era molto frequente. Doveva studiare molto latino, pregare e fare esercizi ginnici, gli seccava soprattutto essere chiamato “Rus”. Passò in collegio tutto il periodo della guerra, ogni volta che suonava la sirena doveva correre in rifugio, anche contro voglia. Ricorda ancora le incursioni dei bombardieri americani che rombavano come treni, dopo ogni bombardamento rimanevano sulla strada cavalli morti. Ricorda come i tedeschi ammazzavano mucche e maiali. Le cose cambiarono con l’arrivo degli americani, perché davano qualche cosa da mangiare. Edoardo, lasciato il collegio, ritornò a Roma dalla madre. La padrona dell’albergo dove lavorava Caterina, resasi conto dell’eccessiva magrezza del ragazzo, cercò di dargli cibo nutriente per farlo ingrassare. Dell’infanzia trascorsa a Roma, ricorda soprattutto le partite di pallone ed i giorni in cui andava a raccogliere castagne. Ben presto dovette andare a lavorare. Fu costretto a fare mille mestieri prima di venir assunto nella libreria dei fratelli Croce, posta sotto la tipografia dove veniva stampata “L’Unità”, il giornale del “Partito Comunista Italiano”. Dopo la guerra ci furono continue controversie tra comunisti e democristiani. Purtroppo per la famiglia Rugo, i padroni dell’albergo vendettero ogni cosa e partirono per l’Argentina, temendo che i comunisti salissero al potere. Il potere, invece, venne preso dai democristiani. Fu difficile la vita anche per i due figli di Sante: Dante e Rodolfo. Quando arrivarono in Italia Rodolfo aveva 20 anni, Dante 16. Era indispensabile cercare un lavoro ed imparare l’italiano. Vennero anche chiamati sotto le armi. Dante, dopo aver combattuto in Jugoslavia contro i tedeschi, fu internato in un campo di concentramento, dove venne liberato dei russi. Qui incontrò una giovane di Torino, imprigionata per aver dato una sberla ad un tedesco e si innamorò di lei. In seguito i russi li aiutarono a sposarsi. Anche Rodolfo venne rinchiuso in un campo di concentramento. Tutti si erano iscritti al “Partito Comunista Italiano”: Caterina, Amanda, Dante, Rodolfo, Edoardo, che prima aveva fatto parte di un gruppo di “Giovani Comunisti”. Quanto Albina, nel 1949, uscì dal collegio cercò un lavoro, ma poiché non aveva imparato nessun mestiere, andò a fare la bambinaia in una famiglia. Edoardo, quando fu costretto a presentarsi per prestare servizio militare, dichiarò apertamente di voler entrare nell’esercito sovietico. Poiché il suo sogno era quello di tornare in Russia, cominciò a preparare la partenza. Anche Caterina Gurova desiderava con tutto il cuore morire in patria. Dante e Rodolfo, invece, la pensavano diversamente, infatti, le loro mogli erano italiane e contrarie alla partenza. Rodolfo aveva anche una bambina che stava crescendo e la moglie non avrebbe mai accettato di allontanarsi dall’Italia. Tutti ricordavano come si viveva bene ad Irkutsk prima della guerra, pensavano che là non fosse cambiato niente. Anche Albina non voleva rimanere in Italia, voleva partire assieme alla mamma. I fratelli Croce avevano cercato di dissuaderle, ma i loro discorsi erano vaghi, fatti di allusioni. Probabilmente sapevano molte più cose di quelle che dicevano, però non si pronunciavano mai chiaramente. Edoardo, in modo ostinato, ripeteva di voler ritornare in patria, si sentiva russo, legato a quella terra, per questo voleva prestare servizio nell’esercito sovietico. Al momento della partenza gli strinse la mano nientemeno che il segretario generale del Partito Comunista Italiano: Palmiro Togliatti . Edoardo rimpatriò per primo, era il febbraio 1955 e in Russia si era in pieno inverno. Sua madre e sua nonna, forse, si erano dimenticate del gelo e non gli avevano dato abiti sufficientemente caldi. Arrivò, così, a Mosca con un cappotto poco pesante, pantaloni leggeri, scarpe basse e senza colbacco, con i vestiti “foderati di vento”, come dicono in Russia. Per raggiungere Irkutsk il treno impiegò sette giorni. Edoardo si aspettava di trovare in stazione ad attenderlo, il nonno. Nessuno, invece, gli era venuto incontro, per questo cominciò ad avere paura. La gente intorno a lui indossava il “tulup”, una pelliccia economica, ai piedi aveva i “valenchi” (stivali di feltro per l’inverno), in testa portava copricapi con i paraorecchi e, per la prima volta, vide anche facce tipicamente asiatiche. Per fortuna assieme a lui, che non sapeva parlare il russo, aveva viaggiato una giovane donna. Alla stazione gli fece un po’ di compagnia, in attesa che arrivasse il nonno, ma, visto che non arrivava, aiutandosi con dei gesti, gli spiegò che sarebbe ritornata la mattina seguente e che, se nessuno si fosse presentato, lo avrebbe aiutato nella ricerca. Edoardo attese fino al mattino, ma nessuno si fece vivo, non sapeva che erano già passati tre anni dal giorno in cui il nonno era morto. Quando al mattino arrivò la giovane, lo accompagnò alla polizia. Chiarito l’indirizzo, attraversarono la città con un tram simile ad una scatola aperta che correva sulle rotaie. Edoardo prese parecchio freddo. In via Geliabov trovò l’appartamento dei nonni: una sola stanza posta in un seminterrato, con dentro una stufa, tre letti e un tavolo. Almeno era caldo. Si gettò su di un letto e dormì fino a sera, quando rientrò dal lavoro la nonna che non aspettava l’arrivo di nessuno. Invece, ecco lì, davanti a lei, un nipote dagli occhi grandi, straniero, piuttosto gracile che non conosceva neppure una parola di russo. Si spiegarono a gesti, come tra sordomuti. Venne subito assunto al 10° reparto della fabbrica Kuibiscev, come apprendista elettrosaldatore. Secondo la nostra usanza gli fu insegnato a bestemmiare, ma non riuscirono mai a fargli bere vodka. Per lungo tempo Edoardo non riuscì ad abituarsi al mondo che lo circondava e che non riusciva a comprendere, tutto gli sembrava brutto, la gente indossava colbacchi spelacchiati e ogni cosa era malandata e vecchia. Con disperazione pensava al giorno in cui sarebbero arrivati gli altri, in quella piccola stanza posta in un seminterrato, dove già abitavano in quattro. Non poteva scrivere che si viveva male. Il Principale gli aveva fatto capire che certe cose non si potevano scrivere. Nel novembre dello stesso anno arrivarono tutti gli altri, che non sospettavano neppure alla lontana la realtà che li attendeva. Caterina ed Amanda, al loro arrivo in Italia, avevano trovato una situazione molto migliore. Tutte e due non avevano dimenticato la madre lingua. Albina aveva creduto di fare un viaggio turistico, non di rientrare in patria definitivamente. La sera dell’arrivo delle tre donne, come era naturale, tutti vollero festeggiare. Ad Albina versarono in un bicchiere del liquido trasparente e le dissero: “Bevi l’acqua del fiume Angara”. Bevve di un fiato, come si beve l’acqua fresca, ma il liquore le andò di traverso, facendole vedere tutte le stelle del firmamento... Solo quando Edoardo disse: “Allora! Adesso siamo arrivati!”, capì che erano rientrate per sempre, che non sarebbero più ritornate in Italia. Dopo aver pianto per ventiquattro ore perché non avrebbe più rivisto la sua “Cara Italia” fu presa da una gran disperazione. Amanda trovò subito lavoro, Caterina non lavorava più da tempo perché troppo anziana e si faceva mantenere dalla figlia. Diversa la situazione di Albina che non parlava la lingua russa, non aveva una professione, per questo le fu particolarmente difficile abituarsi alla nuova vita. Andò a cucire in una fabbrica, all’angolo tra le vie Bolsciai e Proletarskaia. In un giornale venne pubblicato un articolo in cui si parlava di una giovane italiana, che aveva sempre sperato di ritornare in patria, ora, finalmente il suo sogno si era avverato! Ogni parola di questo articolo era falsa, il giornalista non era stato capace di capire quello che c’era realmente nell’animo di Albina, che ebbe paura a dire la verità. Edoardo non realizzò il suo sogno di entrare nell’esercito sovietico. Fu, infatti, esonerato: la fame patita durante l’infanzia aveva lasciato le sue tracce, così come aveva fatto il freddo preso durante il lungo viaggio. Si era ritrovato con un’ulcera gastrica, un inizio di psoriasi soprattutto aveva compromesso il sistema linfatico. Anche se tutti erano stati iscritti al “Partito Comunista Italiano”, non poterono mai entrare a far parte dell’amato “Partito Comunista Sovietico”. Solo Caterina Gurova potè realizzare il suo sogno: morire in patria. Questa fu l’unica sua consolazione, accanto a quella di aver trovato, nel cimitero Lisichinskoie, le tombe del padre e del nonno. Amanda morì il 5 novembre 2002. Probabilmente fu l’ultima discendente di russi italiani. Amanda ed Edoardo non videro più l’Italia, Albina, invece, ritornò per ben due volte. Assieme agli amici ammirò le bellezze di Venezia, Firenze, Roma, ritornò a camminare lungo il vicolo vicino Fontana di Trevi, dove aveva trascorso l’infanzia. Edoardo, oggi, quando sente nostalgia, ascolta canzoni italiane assieme alla sorella e a quelli che parlano italiano. E sogna di morire in patria, nel piccolo paese di Campone, dove abita Eva, la figlia dello zio Rodolfo. Oggi si sente più italiano che russo, in Italia ha trascorso un’infanzia e una giovinezza difficili, ma non la può dimenticare. In che modo si possono aiutare le persone sulle quali le catastrofi del XX secolo sono passate come un rullo? La famiglia Rugo mi ha raccontato le peripezie che ha passato, sperando di riottenere la cittadinanza italiana. |