|
Buje: monede false: monede vere? Dritto e rovescio di una famosa espressione popolare nel romanzo di Piero Chiara “Vedrò Singapore?” e nella medaglia di Piero Monassi per il Premio “Fevelìn di Buje 2008 di Mirella Comino
| 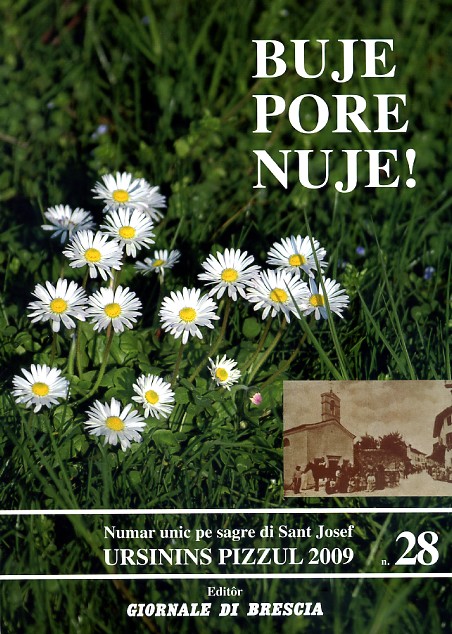 |
| INDIETRO ad Arte |
|
Buje: monede false: monede vere? Dritto e rovescio di una famosa espressione popolare nel romanzo di Piero Chiara “Vedrò Singapore?” e nella medaglia di Piero Monassi per il Premio “Fevelìn di Buje 2008 di Mirella Comino
| 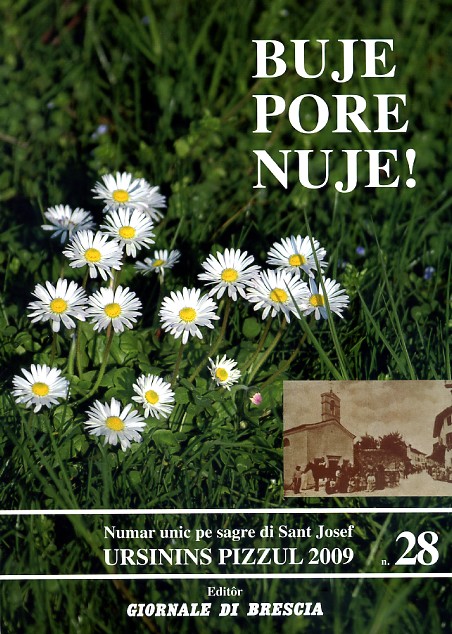 |
| Buje, monede false?... “Buje, monede false” o “fals come la monede di Buje” sono modi di dire diffusi a tutte le latitudini, anche se curiosamente quasi inesistenti proprio nel parlare comune della gente di Buja. Emigranti, turisti, persone che per qualsiasi ragione hanno girato il mondo sono testimoni del fatto che, interrogati sulla loro provenienza ed avendo dichiarato di essere bujesi, si sono sentiti commentare: «Ah, quelli della moneta falsa!». Da parte loro, i bujesi non di rado vengono a conoscenza casualmente, magari tramite contatti esterni, della “brutta fama del mio bel paese”, per usare le parole di Pietro Menis[1]. Uno studio accurato delle ragioni filologiche in cui ha messo radici questo modo di dire con i suoi derivati è stato affrontato nel 1996 da Michela Pauluzzo Guerra[2] prevalentemente sulla base di fonti orali; prima ancora Pietro Menis, nella sua antologia di “Lejendis di Buje”, ne dava la versione raccolta presso Nino Barnaba, precisando che si trattava comunque di tradizione non scritta, ma tramandata molto diffusamente. Da questi studi esce complessivamente un quadro di ipotesi diverse, non confortate da certezze documentali e quindi di sapore leggendario, che vanno dall’uso di un’improbabile stampatrice, fatta funzionare sbattendo l’anta di una porta, all’iniziativa di sette burloni di nome Angelo (da cui “La Compagnia dei sette Angeli”), che beffarono la guardia asburgica realizzando monete del tutto simili a quelle in progetto di corso legale, con tanto di effigie di Francesco Giuseppe, ma recanti la dicitura “Regno di Buja”. C’è poi, con più chiara evidenza storica ma senza concreti elementi di reato, la ben nota emissione di banconote cartacee da parte dell’autorità comunale durante l’occupazione austriaca del 1917 - 18, quando la mancanza di denaro liquido fu affrontata dalle autorità locali accordando la circolazione di buoni da riconvertire in moneta legale “entro sei mesi dalla conclusione della pace”: un provvedimento che, con modalità dettate da analoghe ragioni, non fu unico in quegli anni di emergenza economico finanziaria, ma soprattutto istituzionale; comunque una disposizione forse non ineccepibile sotto il profilo della precisione giuridica, ma neanche macchiata di disonestà. Si può aggiungere infine, forzando un po’ arbitrariamente gli indizi in favore del binomio “Buja - moneta falsa”, l’episodio efficacemente ricostruito da Gemma Minisini Monassi[3], con fonti documentali della collezione di Umberto Aita, riguardante il processo subito a San Daniele nell’aprile del 1815 da tal “Giovanni di Francesco Caligaro nato e domiciliato nella comune di Buja, nel borgo di Sopramonte”. Dopo una notte in prigione ed un pesante interrogatorio, cui erano seguiti accertamenti presso le autorità bujesi, il giovane in questione, che faceva il negoziante, fu allora assolto dall’accusa di aver spacciato volontariamente al mercato di San Daniele monete false da 50 centesimi, che egli aveva avuto verosimilmente in pagamento da ignoti avventori della sua bottega ed utilizzato in perfetta buona fede per pagare i suoi acquisti. Questa, a grandi linee, la sintesi di quanto è più o meno risaputo, con ridondanza di varianti, circa una vox populi che naviga tra insondabili realtà e imprecisate leggende. Ma quante e quali saranno mai le tessere del mosaico originario, quello da cui, ad un certo momento della storia, si sono levate le prime chiacchiere a raccontare che Buja era patria di falsari? L’indagine è aperta, e il passare del tempo, lungi dallo sgrovigliare l’intreccio di indizi, ogni tanto ne porta alla luce di nuovi, magari ripescati tra scartoffie in attesa di rendersi utili. E così, riprendendo in mano la lettura di “Vedrò Singapore?”[4], un vecchio romanzo di Piero Chiara più volte cominciato e mai approdato a pagina 170, proprio all’inizio della prima riga di quella pagina ho incontrato con sorpresa la parola “Buia”, scritta con la “i” e quindi per un attimo, ma solo per un attimo, confondibile con il genere femminile dell’aggettivo “buio”. Riporto il testo tale e quale, a partire dall’ultima proposizione di pagina 169, precisando, per chi non avesse letto il libro, che il romanzo è ambientato nel Friuli degli anni ’30 e narra in forma autobiografica la vicenda di un giovane impiegato dell’amministrazione giudiziaria, che nel suo primo anno di servizio viene mandato da una sede all’altra, da Pontebba, ad Aidussina, a Cividale, con ripetuti provvedimenti punitivi dovuti all’antipatia che aveva suscitato nel suo superiore, l’Alto Commissario Mordace. Un caso di mobbing del Ventennio, insomma, lungo il quale si incontrano personaggi e colpi di scena che fanno nascere nel protagonista il desiderio di espatriare a Singapore. Ed ecco il testo, da pag. 169 a pag. 171, dove si nominano di sfuggita un certo maresciallo Coniglio e la Ilde, la ragazza cividalese di cui lo stesso protagonista si era innamorato. «Mi venne in mente l’affare della Banca di Buia, scoppiato da poco, e tutto mi parve chiaro. Qualche mese avanti, a Udine, nello stesso caffè dov’ero seduto col Coniglio, due sfaccendati si erano preso il gusto di decifrare le scritte microscopiche inserite nel disegno dei biglietti da cinquecento lire per renderne difficile la contraffazione. La banconota, che dopo il biglietto da mille lire era la seconda in ordine di valore, aveva nel mezzo un grosso cinque seguito da due zeri di uguale grandezza. Le cifre erano composte, nel disegno, da una miriade di tasselli in finto rilievo su ognuno dei quali si leggeva “Banca d’Italia”. Tra quelle migliaia di scritte tutte uguali e quasi invisibili senza l’aiuto di una lente d’ingrandimento, uno dei due sfaccendati ne scoprì una, nel dorso del cinque, nella quale si leggeva, anziché “Banca d’Italia”, “Banca di Buia”. Buia è un paese del Friuli, a una ventina di chilometri da Udine. Diventava chiaro che il biglietto era stato abilmente contraffatto e che i falsari avevano inserito la scritta “Banca di Buia” per scherno, per eccesso di sicurezza o forse nell’intento di sfuggire, se scoperti, alla condanna. Era infatti comune opinione che se il biglietto di banca contraffatto non imitava in tutto e per tutto l’originale, non vi fosse reato. Un quarto d’ora dopo tutti i possessori di banconote da cinquecento lire cercavano la scritta “Banca di Buia” nella curva del numero cinque. Di biglietti falsi ne vennero trovati a migliaia anche nei forzieri delle banche, perché la contraffazione era perfetta e la qualità della carta pressoché uguale a quella impiegata dalla Banca d’Italia. Nei giorni successivi, a Buia veniva scoperta nella cantina di una villa la zecca clandestina. Seguirono numerosi arresti e l’identificazione di un certo numero di spacciatori, fra i quali capitò il fratello della Ilde per il solo fatto che era amico del figlio, paralitico, di uno dei falsari. Si era sospettato che avesse partecipato allo spaccio passando dei biglietti falsi avuti dall’amico alla sorella, cassiera di un esercizio pubblico. Ma venne subito rilasciato quando si constatò che l’incasso giornaliero al Caffè Longobardo non arrivava mai a un totale di cinquecento lire…» Vero? Falso? Verosimile? A quali fonti attinse Chiara per una citazione così precisa dei fatti? Quale può essere stata la villa in cui i falsari avevano messo in opera il loro laboratorio clandestino? E chi possono essere stati essi stessi, di cui uno con un figlio paralitico? Si sa che i romanzi cosiddetti storici innestano accadimenti nati dall’inventiva dello scrittore in ambienti dalle coordinate spazio temporali e socio culturali piuttosto rigorose, e che lo sfondo su cui si muovono i loro personaggi rappresenta quanto meglio possibile quadri di storia generale e locale ricavati da studi attenti e documentati. Fantasia e realtà, insomma, convivono intrecciandosi in diversa misura e con diversi gradi di attendibilità: un po’ quello che accade, certamente con maggior peso della componente fantastica, in ogni leggenda che si rispetti, e quella della moneta falsa di Buja, per quanto se ne sa fin qui, non fa eccezione. …o Buje, monede vere? Certezze e non indizi, invece, sono inconfutabili nella realtà dei nostri grandi medaglisti, alcuni dei quali creatori di monete di corso legale (se non addirittura, come Pietro Giampaoli e Guerrino Mattia Monassi, capi incisori della Zecca di Stato), che ormai da dieci anni troviamo in esposizione permanente nel Museo della Medaglia d’Arte e della Città di Buja . Gianfranco Ellero titolava “Le vere monete di Buja”[5] la sua introduzione al catalogo delle loro opere, esposte nel 1996 in una quarantina di esercizi pubblici del territorio comunale. Rendeva merito, con ciò, al valore di capolavori concreti “modellati secondo i canoni dell’arte” da mani che avevano saputo creare anche le 500 lire con il profilo di Letizia Savonitti o le 100 lire con il ritratto di Guglielmo Marconi. Monete vere, dunque, e al tempo stesso opere di un valore artistico che non ha reticenze ad entrare in un alone di leggenda: di questo è altresì convinto Piero Monassi, egli stesso maestro incisore e figlio dell’arte bujese, nonché nipote e allievo dell’indimenticabile Guerrino Mattia, che su richiesta della Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione ha realizzato nel 2008 la medaglia per il Premio “Fevelìn di Buje ”. Il tema che la SOMSI proponeva per l’edizione di quel premio aveva per titolo “I nestris mûts di dî”, e metteva con ciò in azione tra gli alunni delle scuole (i più assidui partecipanti all’iniziativa) ed eventuali appassionati adulti una ricerca su quelle espressioni metaforiche, similitudini, esclamazioni che coloriscono il linguaggio comune e danno efficacia alle comunicazioni verbali. Un tema difficile per la sua illimitata ampiezza: si trattava di far entrare in un piccolo tondo di metallo un intero universo di espressioni dalle tante sfumature semantiche, ma anche storiche, culturali e sociali, veri e propri squarci di micro cultura. Bisognava inoltre rendere riconoscibile con pochi segni plastici il contenuto immateriale di un parlare prevalentemente basato su inferenze ed allegorie. Si doveva infine stabilire quale, tra le centinaia di espressioni emergenti nel linguaggio comune, fosse più efficace per documentarne tutta la forza comunicativa. Nessun dubbio per Monassi: preso in considerazione il fin troppo celebre “Buje monede false”, lo ha ribaltato alla luce dell’altra, ben più nobile realtà dei più grandi artisti bujesi della medaglistica e della numismatica del XX secolo, ed ha centrato la sua composizione su un inedito ma concreto “Buje Monede vere”. Ed ecco che, nel bronzo per la SOMSI, le famosissime 500 lire di Pietro Giampaoli col profilo rinascimentale della moglie, le 100 lire dello zio Guerrino Mattia con lo splendido ritratto frontale di Marconi e le 500 lire dello Stato Vaticano coi simboli pontifici, opera di Celestino Giampaoli, sono le tre monete “vere”, intorno alle quali si sviluppa tutto l’armonioso e raffinato assetto estetico e compositivo in cui si dispongono nastri intrecciati, recanti le iscrizioni illustrative del tema. Il “BUJE MONEDE VERE”, che sfida la tradizione, è bilanciato da un “FALS COME LA MONEDE DI BUJE”, che ha il compito di riportare la rappresentazione grafica all’argomento dei “mûts di dî”; entrambe le scritte sono incorniciate da altri frammenti di lingua e saggezza popolare friulana: BALÂ SUNTUN BÊÇ (= ballare su un soldo,) per descrivere chi ha grande agilità; INDI Á FATIS TANTIS CHE PITAC (= ne ha fatte quante un certo Pitac) per denunciare l’attitudine a combinarne di tutti i colori; SEI UN BIDIN per definire chi è sempliciotto; ÂSTU PÔRE DI MURÎ CENCE PREDI? (= hai paura di morire senza prete?) per interrogare chi si dà fin troppo da fare, come se si trattasse sempre dell’ultima occasione di questa vita ; MÂL DI LEÂ CUL PEÇOT (= male da fasciare con una pezza), per commentare l’entità di un malanno, anche non fisico; PATAFÂSI LA BOCJE (= prendersi a schiaffi sulla bocca) per esprimere il rammarico di dover rinunciare a qualcosa; BUTÂLE IN STAIARE per indicare come si sdrammatizza una situazione. Accanto a queste locuzioni tuttora vive nel parlare comune di molti bujesi, anche se non strettamente appartenenti al solo territorio locale, ce ne sono altre, tipiche ed esclusive della “bujesità culturale”: AMBUI E CUARGNUI (= i frutti dolci del susino mirabello e quelli duri del corniolo) per ricordare un vecchio scambio di apprezzamenti un po’ velenosi tra gli abitanti di Santo Stefano e quelli di Madonna; BUJE PÔRE NUIE (= Buja, niente paura) per tener vivo il coraggio che i bujesi hanno sempre dimostrato nelle difficoltà; BRUSÂ L’AVENT, per far memoria della tipica espressione bujese con cui si intende l’accensione del fuoco epifanico, che nel resto della regione prende altri particolarissimi nomi, dal celebre “pignarûl” di Tarcento ai vari “pan e vin”, “arbolat” “femenate” o più semplicemente “fûcs” di altri paesi friulani. L’iscrizione 2008 - FEVELÌN DI BUJE - MÛTS DI DÎ richiama doverosamente le finalità celebrative dell’opera, mentre DÎS AGNS DAL MUSEU DA L’ART DE MEDAE ricorda che sono ormai trascorsi dieci anni da quando il museo della Medaglia d’Arte è diventato la casa delle “vere” monete di Buja: una realtà che sempre più decisamente, a giudicare dal numero e dall’interesse dei visitatori, va a portare a tutte le latitudini la “bella fama del mio bel paese”.
[1] “E je ben cognossude in lunc e in larc la brute fame dal gno biel paîs”: da Regno di Buje – Monede false in “Lis Lejendis di Buje” a cura di Pietro Menis, Udine, 1928, riedito nel 1981 dalla SFF, con prefazione di Novella Cantarutti. [2] La leggenda di Buje monede false di Michela Pauluzzo Guerra in “Buja città d’arte della medaglia - omaggio agli incisori”, catalogo della mostra a cura di M. Comino per il Comitato Commercianti Esercenti ed Artigiani e Comune di Buja, Buja, 1996 [3] Un giorno del 1815 tra i banchi del mercato di San Daniele di Gemma Minisini Monassi in “Buje Pôre Nuje” n.20, 2001 [4] Vedrò Singapore? di Piero Chiara, Mondadori, 1981 [5] In “Buja città d’arte della medaglia - omaggio agli incisori”, cit. |