| Conti e contadini - tutti cugini di Remo Molinaro | 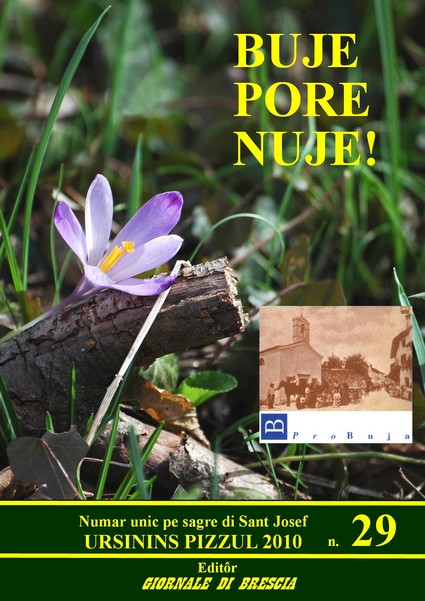 |
| Conti e contadini - tutti cugini di Remo Molinaro | 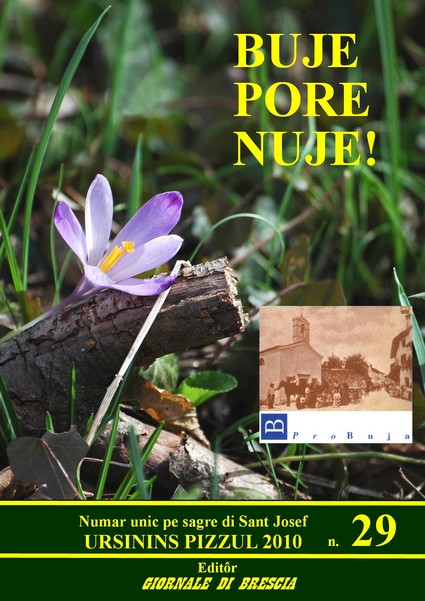 |
| «Sto organizzando la prossima escursione in Italia e vorrei visitare il Friuli. Puoi aiutarmi?» Era Emanuele al telefono, il presidente della “Società Dante Alighieri Comitato di Lucerna”. Gli chiesi, se sapesse quanto lontano sia il Friuli, quanto povero d’arte e di paesaggi spettacolari. Gli dissi, che il Friuli per secoli è stato, tra Venezia e Vienna, terra di nessuno, zona di confine, di mitragliatrici e soldati, e che di quel poco che aveva da offrire, molto era stato distrutto dal terremoto nel 1976. Tutto questo non lo interessava. «Tu sei friulano - rispose - e vogliamo vedere da dove salti fuori». Il presidente, come si deduce dal nome, è piemontese, piemontese vero. Ha studiato a Torino e si è trasferito in Svizzera - per amore, non per profani motivi economici. Ma sopratutto è un discendente di Carlo Francesco Bellingeri, medico di corte di Vittorio Emanuele II e membro dell’accademia reale delle scienze. E come se non bastasse, tra i membri della “Dante” di Lucerna ci sono diversi professori, tra l’altro il dott. Alois Schacher, docente all’Università di Udine - ripeto: Udine - di un corso intitolato: “Il libro a stampa come prodotto tecnico e come strumento per lo sviluppo della scienza, della libertà del pensiero e per l’alfabetizzazione delle masse.” Cosa potrebbe offrire il Friuli a chi è abituato a visitare palazzi reali, duomi grandiosi e musei di fama mondiale in Lombardia e Piemonte? In qual modo avrei potuto evitare un “fiasco dantesco” nel povero Friuli? E in fondo, da dove “salto fuori”? Sono figlio di emigrati, uno dei tanti sparsi per il mondo. In cento anni più di un milione di friulani, almeno quanti ne vivono oggi in Friuli, sono emigrati definitivamente. Parlo il Friulano e scrivo più male che bene in Italiano, tanto da dovermi far correggere anche i testi più brevi, prima di poterli stampare su “Buje pore nuje!”. Oltre tutto, la mia famiglia non proviene da San Daniele o Venzone, ma da Pers, che non è mai stato un gioiello e dopo il terremoto lo è ancor meno. Passando per il paese si nota sì una nuova chiesa con una bella torre. Ma dove c’era una grande e caratteristica piazza con le tipiche case friulane, oggi si vede sopratutto uno squallido parcheggio. No, con paesaggi ed architettura non avrei potuto incantare la “Dante di Lucerna”. Ci voleva altro. Non solo sono figlio di emigrati, sono anche discendente di una lunga serie di “illitterati non possidenti” ben documentata nei libri dei battesimi e dei morti - che poi non sono altro che i libri delle “entrate e uscite” - delle parrocchie di Colloredo di Monte Albano e di Pers di Majano. Il primo sulla lista dei “Mol[l]inari illitterati” è Mattia, detto “Agnolino di Colloredo del borgo di Corte maggior”, padre di Antonio, morto il 23 Novembre 1788 all’età di 80 anni. Di conseguenza, i genitori o nonni di Mattia non solo erano dello stesso luogo, ma anche coetanei di Ermes di Colloredo, il grande poeta friulano, nato nel 1622 a Colloredo e morto nel 1692 a Gorizzo di Camino al Tagliamento. Se non posso vantarmi di un nonno medico del re, ho almeno antenati che mungevano il latte e raccoglievano le uova per la colazione del piccolo Ermes, un bambino biondo - la famiglia dei Colloredo era di origine tedesca - destinato a diventare il “Piccolo Dante” della poesia friulana, con la quale si contrappose in modo rivoluzionario alla classe aristocratica che scriveva prevalentemente in italiano ed alla quale apparteneva. Inoltre ho un altro asso nella manica: Ciro di Pers, cugino di Ermes ed uno dei grandi poeti italiani del Seicento, nato nel 1599 in quel paese col parcheggio squallido e morto sempre lì nel 1663. Con questi “paesani” potevo affrontare tranquillamente l’avventura della “Dante di Lucerna in Friuli”. L’immagine di contadini che mungono vacche e raccolgono uova per il figlio di un barone sarà romantica, ma di sicuro non è realistica. Gli “Agnolini” di Colloredo, nel Seicento, mungevano, raccoglievano e consegnavano, non per amore della poesia o della patria, ma perchè dovevano. Erano “angeli” di nome, non di fatto. Non vivevano in cielo - in quello ci “volavano” una gran parte dei neonati e d’inverno mezze famiglie - ma campavano sulla terra, e dovevano lottare per sopravvivere. Se potevano si assicuravano la loro parte di latte e uova, sebbene tutto - case e stalle, mucche e galline, alberi e frutti - appartenesse al barone e si dovesse fare attenzione. Basti ricordare che la “joibe grasse” del carnevale del 1511, probabilmente la rivolta contadina più brutale del Rinascimento Italiano e sfondo storico della tragedia “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, con una cinquantina di nobili, sostenitori dell’Impero Austriaco, ammazzati, tagliati a pezzi e dati in pasto alle bestie sulle strade e piazze di Udine, al tempo di Ciro di Pers e di Ermes di Colloredo era passata solo da pochi anni dalla memoria degli ultimi testimoni alla storia. Non è probabile, ma non si può nemmeno escludere, che nell’assalto al castello di Colloredo, colla sua distruzione parziale, avvenuto in seguito alla “joibe grasse” e condotto dai contadini del luogo (o dai “Zambarlani”, sostenitori della Repubblica di Venezia, scacciati da Udine), da una parte o dall’altra ci sia stato anche un “Angelo - Agnolino” - con l’ascia in pugno. Se c’era, di sicuro non morì in lotta senza lasciar prole. Inoltre: La “vendetta” tra le “famiglie” friulane degli “Strumieri”, ai quali appartenevano i Colloredo, e degli “Zambarlani”, venne tollerata dai Veneziani fino a dopo la metà del Cinquecento, per poi fare posto ad un’ istituzione più moderna ed “evoluta” per liquidare litigi: il duello. Ma non illudiamoci. L’evoluzione è lenta; il mondo non cambia tanto in fretta. Come 500 anni fa - ormai mancano mesi al carnevale 2011 - gli “Zambarlani” istigarono gli “illitterati e non possidenti” friulani, così oggi la ‘Ndrangheta” aizza gli “illetterati e non possidenti” di Rosarno ... Comunque gli “Agnolini” di certo non recriminavano il fatto d’ essere “illitterati”, ma quello d’essere “non possidenti”, che voleva dire patire la fame, soffrire il freddo e morire giovani, di malattie. Non avevano avuto l’occasione di seguire il corso del dott. Schacher all’Università di Udine e perciò non potevano sapere che le due cose, l’”illitterato” e il “non possidente”, andavano a braccetto... Ma anche per i nobili la vita non era uno spasso: Ciro di Pers ed Ermes di Colloredo lasciarono le loro famiglie a 14 e 15 anni; il primo per iscriversi all’università di Bologna, il secondo per diventare paggio del granduca di Toscana, Ferdinando II de’ Medici, a Firenze. Non era la morte - mio nonno nel 1895, a solo 8 anni, accompagnò i suoi zii in Ungheria, e non per motivi di studio, ma per fare mattoni - ma andare via a 14 o 15 anni è perlomeno in chiaro contrasto col moderno ideale del maschio italiano, di restare in casa dei genitori finché genitori ci sono … Poi c’era il problema di trovare moglie o marito. I castellani non potevano sposare “un mul o une mule” qualsiasi, dovevano scegliersi tra di loro, anzi tra le famiglie appartenenti al loro partito, il partito degli “Strumieri”. Era come cercare un ago nel pagliaio. Se si trovava più di una cugina o un cugino da sposare, si era fortunati. E fatta la non facile scelta, si doveva ottenere dalle corrispondenti famiglie il permesso per il matrimonio. Ciro di Pers soffrì tutta la vita per non aver potuto sposare sua cugina Taddea di Colloredo, chiamata Nicea nelle sue poesie. Deluso, entrò nell’Ordine gerosolimitano dei Cavalieri di Malta. Forse, se i Colloredo fossero stati d’accordo col matrimonio, Ciro di Pers non sarebbe diventato poeta, ma uomo felice, o almeno contento.
L’uom, che sí poche della vita ha l’ore e ne conta a fatica una gioconda, è di sospir di pianto un’aura un’onda, piangendo nasce e sospirando more. 1
Barone vuol dire “libero”, non costretto a rimanere a casa, a mungere le vacche. Un conte invece di entrare in un Ordine, poteva anche fare qualcosa d’altro, per esempio la guerra. Ermes di Colloredo, dopo essere stato “ammaestrato negli studj delle lettere in Toscana s’invogliò di quei della guerra” (Vita del conte Ermes de’signori di Colloredo, pp. LVIII, in: “Poesie scelte” edite ed inedite in dialetto friulano da Ermes co. di Colloredo, Udine 1992, copia anastatica del I volume, stampato a Udine dai Fratelli Mattiuzzi nel 1828), diventò ufficiale nell’ esercito di Ferdinando III del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, partecipò alla Guerra dei Trent’anni, ottenne onori e riconoscimenti - per poi vedere suo fratello Giovan Battista morire sul campo. Scrivendo queste righe mi rendo conto che sono fortunato a discendere da “Illitterati” – primo, perchè visto che vento tirava una volta, preferisco essere discendente piuttosto che antenato, secondo, perchè da “Litterati” si rischia di non discendere affatto. Più ci penso e più questa faccenda delle discendenze mi fa pensare: se supponiamo di 34 anni la durata media di una generazione, io che sono della classe del 1954 teoricamente discendo da 16’384 persone nate nel 1478. Sedicimila persone corrispondono più o meno al 10 per cento della popolazione totale del Friuli di allora; e questi miei sedicimila antenati se non fossero morti prima, nell’anno della “joibe grasse” avrebbero avuto 33 anni. Se è vero che alla rivolta parteciparono tra 4000 e 5000 contadini, allora è molto probabile che tra loro ci fossero stati non solo alcuni, ma decine o centinaia di (lontani) parenti miei - e di ogni altro friulano. E anche tra gli ammazzati, ogni friulano probabilmente potrebbe trovare un antenato. Grazie a simulazioni al computer un gruppo di scienziati sostiene, che tutte le persone oggi al mondo hanno un antenato comune nato circa 300 anni avanti Cristo. In altre parole: basta andare indietro un paio di secoli per trovare qualcuno con cui noi tutti - giapponesi, arabi ed eschimesi, scozzesi, nigeriani e cileni, turchi, veneziani ed austriaci, “Strumieri” e “Zambarlani”, conti e contadini - siamo parenti di sangue. Dopo la guerra Ermes di Colloredo andò, prima alle corte di Vienna, e ritornò poi a casa, a Gorizzo, per diventare non solo il “Piccolo Dante”, ma anche il “Dongiovanni” della poesia friulana. Fu di capelli biondi, e di leggiadre fattezze, fornito insieme d’ogni bella dote d’animo,non che di corpo; benchè si mostrasse forse troppo inclinato agli amori: disdetta solita de’poeti,i quali avendo, per osservazion degli astrologi, Venere in ascendente, par che ne risentan più degli altri l’influsso;2 Non può sorprendere che le poesie di Ermes siano meno tristi di quelle di suo cugino Ciro e spesso concrete e satiriche. E non può sorprendere nemmeno che sia morto “senza lasciar di sè alcuna legittima prole” (Vita del conte Ermes de’signori di Colloredo, p. LXI). Della prole “naturale” la biografia non dice niente ... Lu sbelet, che si petin sul mostaz Ciartis damis dal mond al dì di uè, A lìs fàs semëà, lis fàs parè Just’ tang quadris pichiaz, è tang ritraz. Ma ju marìz e’ son di lor plui maz, A no si aquarzi, a no si ravedè, Che lu fasin ad altris par plasè. Dopo intenzudis a fresc par falu a svuaz. Oh miserie dal mond! oh cecitat Da l’om stolid e uarb, che pur no ‘l viod Mascarade su i voi la veritat! Cussì va, cui cu fide e cui cu crod. A ciarz vez di lascivie, al Dio sfrontat
Cu la proprie müir inalze un vod.3 E ora, a cosa possono essermi utili il Pers ed il Colloredo se voglio aiutare la “Dante” ad organizzare una gita in Friuli? A niente! Perchè potrei raccontare tutto ciò comodamente sul bus, sulla A4, tra Bergamo e Brescia. Non c’è bisogno di venire in Friuli per conoscere poeti e poesie. Bastano un libro ed una lampada ... Per fortuna Pietro Zorutti, nel 1824, pubblicò nello “Strolic”, il suo almanacco, la poesia “Lis raritaz del Friùl”, una breve guida turistica ideale per dimostrare ad una società letteraria cosa sia e cosa non sia cambiato in Friuli negli ultimi 200 anni: A sintì cualchidun, di raritaz Il Friùl a l ’è plen a Martelett; Ma jò, che ài cogniziòn di antighitaz, veramentri no ‘n cjati plui di siett:
Picolitt di Rosàzzis e Chastraz; Spargs di Tresèsin; Ostarie di Plett; Parùssulis di chès di Pordenon; Pressut di Sandenel; Muarz di Venzon.4
Per i miei colleghi della “Dante” che, grazie a Dio, non conoscono il Friulano, tradurrò la poesia del Zorutti come segue: Le meraviglie del Friuli sono la Pieve di San Pietro, il Tocai friulano ed il salame; il frico con patate, gli orti delle case ed il Tagliamento; le piazze di Spilimbergo, le strade bianche di campagna e Cividale; la Loggia di San Daniele, il Verduzzo di Savorgnano e la Chiesa di San Martino a Majano; “Le Motte” di San Eliseo, il “Mont di Buje” e le “Place di Sant Jacum”; il Glicine di Tricesimo, la strada di Paradise e il bosco di Collosomano; i Grifoni di Cornino, ...
Note: 1 - Ciro di Pers, “Miseria umana”, prima strofa. 2 - (Vita del conte Ermes de’signori di Colloredo, pp. LXII). 3 - (Ermes di Colloredo, “Sonetto sopra il belletto che usano le donne d’ oggidì”) 4 - (Pietro Zorutti, Lis raritaz del Friul) |