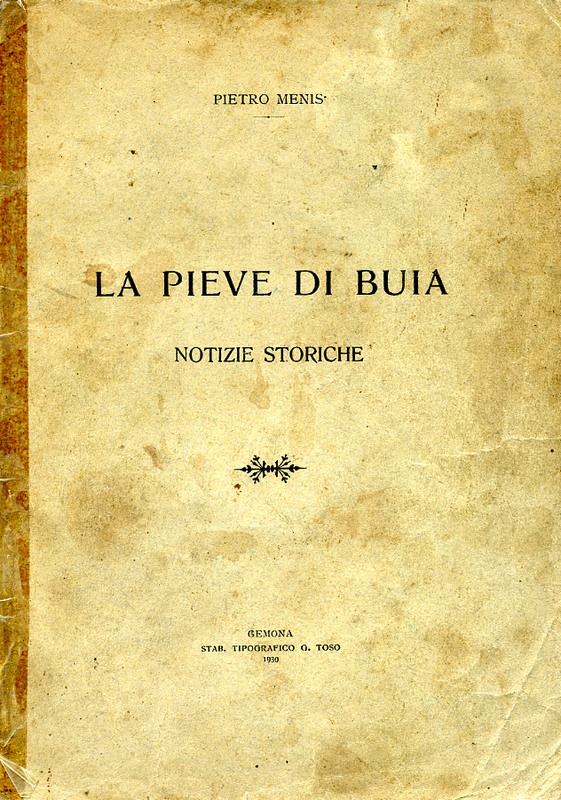
| RITORNA | Capitolo 1 | SUCCESSIVO |
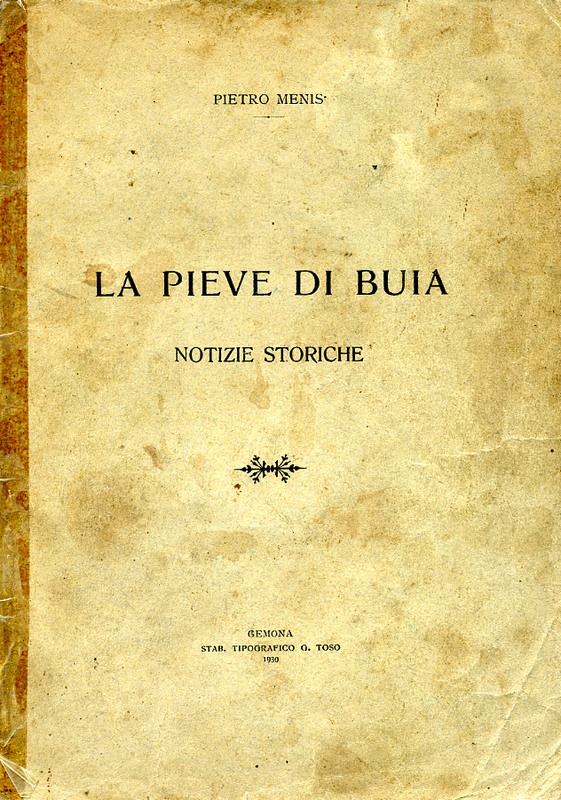
Gemona Stab. Tipografico G. Toso - 1930
| La maestosa chiesa sorge al centro del massimo colle del Comune, intorno al quale tra il verde di altri colli, tra vallette e piani si adagiano i borghi di Buia. Per la prima volta questa Pieve è ricordata in un diploma di Carlo Magno che risale all'801 dopo Cristo, nel quale si legge che il grande Imperatore, nel donare a Paolino Patriarca di Aquileia terre e castella d'Italia, è compresa pure l'“cclesia Sancti Laurentii quae sita est in Foro Julii, loco qui nuncupatur Buga (Buia) cum omnibus facuitatibus suis”. E questa donazione la troviamo confermata nel 983 al Patriarca Rodoaldo di Germania, per opera di Ottone II Imperatore, che vi aggiunse il castello, posto a levante della chiesa, sullo stesso colle, e di cui ci avanzano poche rovine abbandonate. Il quale castello, per certe monete ivi rinvenute, pare che abbia origini romane.6 Dalla Pieve di S. Lorenzo un tempo dipendevano le ville che oggigiorno formano le parrocchie di Vendoglio, Mels, Pers, Farla e Maiano, con le chiese annesse, e tutto il territorio posto nel bacino dell'anfiteatro morenico. Le prime memorie e notizie seguenti alle donazioni di Carlo Magno e di Ottone II si perdono nel buio dei secoli, e prima di averne bisogna arrivare al 1248. E le troviamo in pro-memorie, decreti e fogli esistenti nell'archivio Plebanale, ma sopratutto si ritrovano, e sono le più ricche, in un libro formato di vecchie, corrose e sbiadite pergamene, che Mons. Pietro Venier fece interpretare, e chiamato “Catapane”, - Questo libro venne incominciato a scrivere da Bartolomeo di Vendoglio, prete amanuense, presumibilmente verso il In quell'anno dunque, 1248, si ha memoria che Fulgenzio, Vescovo di Parenzo, ai primi di maggio, consacrava la chiesa di San Lorenzo. A questo prelato, dal Patriarca Pertoldo (1218 - 1248) era stata affidata l'amministrazione ed il governo dei beni di Buia, sottraendoli così, come altre ville della chiesa Aquileiese, alla giurisdizione di giudici laici, che esercitassero condanne o esigessero gravezze. 1251. - Mentre risiedeva in Udine, Gregorio di Montelongo, Patriarca di Aquileia, istituiva i due Vicari della Pieve di Buia. Questo fa supporre che fino allora l'obbligo di residenza non fosse rigorosamente osservato e che i Patriarchi, per provvedere alla cura delle anime, avessero istituiti i due Vicari, i quali avevano tutti i diritti, all'infuori di quelli delle rendite. Come si vedrà, al governo della Pieve, questi Vicari nominati “prò tempore”, prima dai Pievani e poi dai Patriarchi, attesero fino al 1815. 1264. - Si trova nominato il primo Pievano, M. R. Filippo. Probabilmente colla nomina dei Vicari si nominava anche un Pievano titolare senza beneficio, restando questo di competenza alla sede Patriarcale, poichè nel 1303, ai 4 di dicembre, troviamo che Pertoldo, capitano di Gemona, riceveva da Enrico ed Andrea di Buia i frutti ed i redditi che avrebbe ricevuto il Patriarca sui beni di Buia, e cioè: “70 staia granone, misura di Buia, similmente 45 ½ staia fermento, similmente 2 staia fava, meno un pisonale, item 4 quarta di miglio, così pure 38 urne di vino e un conzo di fitto, similmente conzi 17 della Braida dei signori di Buia, rimettendo il resto”. 1310 - 9 febbraio. Ottobono Patriarca raduna il concilio Provinciale, al quale interviene Germano, Pievano di Buia, 1336 - 8 novembre. Il Patriarca Bertrando dispensa dal risiedere in Pieve il Pievano Bertrando di Moltum, che doveva assentarsi per propri interessi. Come si vede, in quel tempo, e forse col cambiarsi di governo, ai Pievani era fatto obbligo di residenza, ma più tardi secondo uso ed abuso, i Pievani non risiedevano; e, oltre ad essere titolari della Pieve, avevano il beneficio in Commenda, costituito dalle decime. I Pievani avevano poi altre incombenze, e forse il beneficio era dato in premio, poichè Pievano fu un Federico di Buia che venne investito il 24 aprile 1349 ed era Canonico in San Pietro di Carnia: un M. R. Leonardo che era Canonico di Cividale (1383), fino ad Alvise o Aloisio Cardinal, Diacono di Santa Maria in Cosmedin, che ebbe a rinunciare alla Commenda e fu, come si vedrà, l'ultimo Pievano titolare e beneficiario. Che i Pievani di Buia rivestissero altre cariche nella gerarchia ecclesiastica si può arguire anche dal fatto che ad essi competeva, nientemeno, l'investire canonicamente i curati delle chiese soggette, come fece nel 1383 un Pievano il 29 giugno per la curazia di Mels che era rimasta vacante. Ma più tardi i Patriarchi rivendicarono a sè il diritto di nomina dei Vicari e dei Curati, anche per mantenere totalmente i loro diritti sulla “loro“ terra di Buia. Terra, che ben a ragione si può ritenere, formasse assieme al castello, il primo nucleo del temporale potere dei Patriarchi in Friuli. Con tutta probabilità il castello, che sorgeva ad occidente del colle di Monte, e di cui le ultime vestigia imponenti scomparvero nel 1909 quando si costruì il fortino, e dove ora sorge il Parco della Rimembranza, doveva essere residenza estiva dei Patriarchi. I quali, da San Paolino a Giovanni di Moravia, tennero, e con savie leggi governarono Buia, salvando i loro diritti anche quando la infeudarono ai Savorgnani nel 1375. Ma non solo alla conservazione del Comune e Castello di Buia, i Patriarchi attesero, ma altresì a tutte le pertinenze della Pieve. Si legge infatti che le ville soggette a Buia, le cui chiese officiavano indipendentemente, e i cui Curati erano beneficiati dai Pievani, tentarono di scuotere il giogo che le legava a San Lorenzo: non tanto dal giogo spirituale, quanto da quello materiale, costituito da quella specie di sudditanza. Poichè gli obblighi verso Dal legame materiale invece, per quanto concerneva il quartese, i curati d'accordo coi singoli Comuni, tentarono di scindersi dalla Pieve. Ma nel 1442 troviamo che Abbiamo detto che i Patriarchi, più tardi, rivendicarono a sè la nomina dei Vicari della Pieve. E difatti, nel 1472, Angelo Fasolo, Vescovo di Feltre, nella sua qualità di governatore generale del Patriarcato di Aquileia, attira a sè la nomina di tutti i Vicari che fino allora solevano nominare o proporre i Pievani, e nomina un certo prete Bartolomeo Bitizato o Bizigato da Murano, Vicario di Santa Maria della Pieve di San Lorenzo di Buia. Si trova spesso citata questa definizione di “Santa Maria nella Pieve di San Lorenzo di Buia” e questo, non credo, sia da confondersi con la chiesa di Madonna, ma trattarsi proprio della Parrocchiale. Ne è prova, che questa venne consacrata anche in onore di: “Sanctae Mariae Virginis” e che ivi esisteva la confraternita di Santa Maria, e l'esistenza tutt'ora di una cappellina dalla volta a botte, incorporata nel fabbricato della chiesa attuale, dove si può ammirare in un trionfo di colori sbiaditi, una serie di episodi che si riferiscono alla vita della Vergine e attribuiti, da competenti, a buona scuola Michelangiolesca. Ma procediamo: questo stesso vescovo di Feltre nel 1473, 12 aprile, nominava altro Vicario della Pieve di Buia, nella persona del frate cassinense Benedetto d'Otranto. In quest'anno 1473 i due sucitati Vicari, si fa per certo che abbiano presa dimora presso le due chiese sacramentali di San Stefano e di Madonna: “poichè essendo Così i due Vicari, risiedendo nei due borghi più popolati e al centro di altri borghi minori del territorio di Buia, cominciarono a dividersi la cura. Questi borghi, da quei lontani tempi, sono sempre stati in antagonismo tra di loro nel campo delle competizioni religiose, le quali, qualche volta, si ripercossero anche nelle civili competenze. Tali dissidi si acuirono in tempi più vicini a noi, dovuti anche al fatto di avere sezionato amministrativamente il vasto e spazioso Comune, per la sua conformazione geografica, in tre reparti che sono divenuti come altrettanti paesi. Questi eleggevano i propri consiglieri, e in seno al consiglio formavano una specie di coalizione avente comuni gli interessi, ma non sempre andavano di concerto, e due reparti bisognava che fossero d'accordo contro l'altro per poter deliberare. E questo principio andò sempre più approfondendo i dissidi religiosi. Restava sempre però alla Matrice la sua giurisdizione, il suo splendore, i suoi possedimenti, le principali funzioni ed ogni prerogativa parrocchiale. Dovevano passare più di cento anni prima che nelle chiese di San Stefano e di Madonna si celebrassero i matrimoni, si battezzassero i neonati, e cioè fino ai primi mesi del 1600. Giungiamo così al primo maggio del 1499 anno in cui il Pievano di Buia, Troiano de Riccardis, di Ortona a Mare, si presentava a Udine al Vicario Patriarcale, Francesco Manzono, e gli esponeva che intendeva rinunciare al beneficio della Pieve. Allora la nostra Pieve veniva data in commenda a Luigi Cardinal, Diacono di Santa Maria in Cosmedin, “affinchè colla sua autorità apostolica, l'avesse tenuta retta e governata”. Ma questo principe della chiesa “spontaneamente e liberamente rinunciava e la consegnava nelle mani di Papa Giulio II° “. Intanto moriva il secondo Giulio e la fabbrica del Duomo di Udine e capitolo, reclamano per loro il benificio della chiesa di Buia. Ciò che ottennero con Bolla di Leone X del 19 Marzo 1512, nell'anno primo del suo pontificato, a perpetua memoria della cosa, dove si legge che, “unisce, annette e incorpora alla chiesa Collegiata di Santa Maria e pressidenti della fabbrica di Udine, Con questa Bolla di unione a Udine Di più si vedeva carpire ogni attributo, ed al decoro del culto era provveduto, cera apparamenti e illuminazione da estranei, cioè dai presidenti della fabbrica di Udine ed i Vicari erano mantenuti poveramente. Che la mensa Vicariale fosse povera si ha la prova che nell'anno seguente all'annessione a Udine, ai Vicari si legano terre e generi in natura, specificando perché ”era scarsa la prebenda e privi di quartese”. E il quartese di Buia, di triennio in triennio, era messo all'incanto, concedendolo al miglior offerente, ed i quartesari dovevano obbligarsi con garanzia, della riscossione e realizzazione della quota spettante alla Collegiata di Udine. Lo dice “il quartesaro Francesco Belgrado cittadino di Udine che nel 1528, addì 28 settembre, supplica li magnifici deputati della città di Udine di non essere la sua total rovina e fargli quel condecente restauro che a quelli pare perchè nel mese di Zugno la grandine, ovvero tempesta, devastò e totalmente rovinò la tavella di Pers, Farla, Maiano e San Eliseo, e rovinato più presto più che meno della mittà di detto quartese, e perchè non spero scoder giozzo de vin in dette ville,,. Così pure supplica pochi anni dopo, il 25 settembre 1539 “il quartesaro della Pieve Costantino de Rizzardis di Buia, perchè una crudelissima e grandissima tempesta fin al presente giorno accorsa in tre fiate nelle ville soggette al quartese, cioè Maian, Farla, Sant'Eliseo, Chiarvà, Vendoi, Treppo Piccolo e Buia”. Abbiamo detto in precedenza, che i Vicari, divisa la cura, non erano sempre d'accordo, e di questa dissonanza certamente ne erano artefici i capi popolo, e qualche volta l'autorità locale. E alla divisione fatta da essi Vicari dovette più volte por mano la sede Patriarcale e I Patriarchi però erano sempre d'avviso ed intenti alla conservazione dell'unicità assoluta della Pieve. Poichè tra l'altre, il 3 luglio 1646 fissava le modalità delle funzioni in Pieve. “Funzionassero nella Matrice alternativamente nelle ricorrenze prescritte, l'uno Vicario, e l'altro presso la sacramentate di sua residenza“. Nel 1650 Marco Gradenigo, su istanza del Comune e uomini di Buia, comandava ai Vicari che servissero il popolouna settimana per uno in tutte le Chiese e attendessero alle sacre funzioni senza impedimenti, e assieme dividessero le offerte. Ma questa nuova sistemazione non dette i frutti sperati, poichè il Cardinale Delfino, Patriarca, in data 23 agosto 1696, specificava le funzioni spettanti a ciascun Vicario nella propria chiesa, e quelle riservate alla Matrice di cui erano investiti. Come si vede, l'investitura era sempre nella chiesa di San Lorenzo, non mai di Santo Stefano e di Madonna. Questa ordinazione trovò il consenso ed il plauso del Comune, il quale delegò quattro uomini, che si presentarono al Cardinale per comunicargli che Ma se questo assestamento permetteva una regolare soluzione nelle questioni, diremo così interne, non cessarono le diatribe esterne, cioè colle chiese filiali, che frattanto erano divenute parrocchie e che sempre dovevano sudditanza all'antica Matrice. I Vicari di San Lorenzo dovettero faticare per mantenere intatto il legame e l'antico dominio spirituale alla Madre. Man mano, queste chiese si esimevano di recarsi, anche l'unica volta in un anno, alla Matrice di Monte: cioè il sabato santo per la benedizione del fonte battesimale, del cero Pasquale da recarsi poi alle proprie chiese, e ritirare gli olii santi. E si trova che in quel giorno alla sacra funzione il curato di Vendoglio era tenuto a fare l'officio di Diacono, quello di Farla di Sudiacono, quello di Pers di Acolito e quello di Mels di Ceroferrario. Ne citiamo qualcheduno: 23 aprile 1586: si impone ai Curati di Vendoglio e di Mels di fare il proprio dovere verso 13 maggio 1661: lo stesso per quello di Vendoglio 4 gennaio 1669: similmente per quello di Pers 23 agosto 1688: ancora a quelli di Vendoglio e Pers Ma a nulla dovevano giovare questi decreti, poichè nel 1702, addì 24 aprile, e 20 marzo 1715, il Patriarca Delfino, li induceva a obbedienza, minacciandoli di sospensione. Il Curato di Mels invece da molto tempo si era dispensato di recarsi in Pieve, e contro di esso i Vicari di Buia ricorsero invano, perchè privi (pare impossibile) di documenti atti a provare la sudditanza della Chiesa di Mels alla Matrice di Buia. Ma anche per questa chiesa i Vicari ed il Comune riuscirono a presentare prove autentiche di dominio spirituale su di essa, provocando una sentenza del Patriarca Daniello Delfino. Nel maggio del Ma poco più tardi con la indipendenza del quartese da Udine e lo sviluppo preso dalle vecchie curazie divenute parrocchie, dovettero morire anche queste ultime consuetudini, questi tenui fili che legavano le chiese filiali alla vecchia Matrice. In conseguenza di queste diatribe, oltre che il suo splendore la vecchia Matrice, andava perdendo i suoi numerosi e vasti possedimenti avuti per lasciti in tutti i secoli: perdeva i legati in natura che venivano impiegati per l'esercizio del culto e il mantenimento dei Vicari. E difatti si hanno numerosi documenti dove si rileva che i Vicari di San Lorenzo litigarono con tante ditte, per indurle ad osservare i fini dei testatarii, e per far valere le loro ragioni sulle cose di pertinenza della Chiesa. E così dicasi delle fraterne spezzate, divise e impoverite. Come quella di Sant'Antonio Abate che nel 1372 già possedeva beni ed era ricca, che a sue spese seppelliva i confratelli, aiutava i poveri e i degenti, e faceva celebrare suffragi. (Quella di Sant'Antonio di Padova invece venne costituita il 30 gennaio 1664). Quella di Santa Maria notata con terre nel 1439 la cui fondazione si perde nei secoli. (Da non confondersi questa con quella del Carmine, istituita nella chiesa di Madonna il 18 gennaio 1649, nè con quella del Rosario a San Stefano, istituita il 1 maggio 1639). Quella del SS. Sacramento (arciconfraternita), istituita nel settembre del 1593, con 12 capitoli di statuto, tutti concernenti al suo decoro e funzionamento. Vi erano inoltre le fraterne di San Rocco, istituita il 15 agosto 1597, quella di San Nicolò, e quella di San Leonardo istituita più tardi, ma che dal cumulo dei testamenti e legati che la riguardano, forse è stata una delle più ricche.
Contro Si riscontra infatti una lunga, e se vogliamo anche dolorosa e umiliante serie di implorazioni, lamenti, ricorsi, processi e minacce, che durarono fino al 1792, cioè per ben 280 anni. Prima di tutto troviamo le rimostranze dei Vicari, per la povertà delle loro mense. Troviamo ad esempio che nel 1562 uno dei Vicari aveva l'entrata annua di L. Questo stato di cose impoveriva e umiliava anche il Comune, che fino nel 1597 assieme ai Vicari ricorse, sia pure invano, al luogotenente della Patria, Nicolò Contareno. E ricorsero cent'anni dopo, nel 1697, agli Ecc.mi giudici Inquisitori di Terra Ferma, perchè la fabbrica del Duomo, per lo sviluppo maggiore avuto dal Comune, non riscuotesse del quartese della Pieve più di 80 fiorini d'oro, come parlava Ma le cose procedevano con lentezza anche allora, poichè soltanto il 18 agosto 1745, dopo altre suppliche, inquisizioni, dichiarazioni giurate, questa formola di accomodamento potè avere la sua soluzione. Intanto anche nelle ville della Pieve i parroci riscuotevano il quartese per proprio conto, sordi ai richiami e allo spirito della Bolla di Leone X. Lo provano carte, documenti, decreti, reconfinazioni ordinate dalla sede Patriarcale, dove risulta che il Comune ed i Vicari tentavano questo per mantenere alla Pieve le sue pertinenze e giurisdizioni, ed i Presidenti della fabbrica del Duomo, perchè si vedevano col sfumare di un cespite, calpestare una legge. Ma nel 1791 “il giorno di domenica 6 febraro, in Buia del Friuli in contrada Santo Stefano nella salla del conseglio situata sulla piazza, ove radunar si suole more solito al tocco di campana sono radunati i capi del Comune, 17 Consiglieri che deliberano di ricorrere con devotissimo memoriale al Governo della Serenissima affinchè alla Pieve sia repristinata l'esazione del quartese”. In seguito vennero esperite le numerose pratiche, deleghe, attestazioni giurate, una delle quali ci piace riportare per la freschezza descrittiva del nostro paese: “1791, 14 aprile. facciamo giurata fede noi sotto scritti pubblici periti, come la villa di Buia di Friuli è composta di Francesco Aita p. p. con giuramento. Gio. Domenico Baracchino p. p. “ Francesco Zonino p. p. “ “ Ed in altro incarto del 16 aprile dello stesso anno troviamo l'elenco delle chiese di Buia che officiavano i Vicari, disseminate tra i borghi formanti corona alla Pieve. A proposito di tali chiese, in fine di queste note, esporremo alcuni dati storici che le riguardano. Dice la nota: “Si fa fede per l'officio di questa giurisdizione de N. N. H. H. signori Coo. Marchesi Antonio e Gerolamo Fratelli Savorgnani come in questa villa di Buia esistono la chiesa Matrice Pieve di San Lorenzo di Buia altra della Madonna altra di San Stefano altra di San Sebastiano altra di San Pietro altra di San Bartolomeo altra di San Floriano altra della S. S. Annonziada altra della B. V. della Neve altra di S. Giuseppe altra di Santa Cattarina altra della S. S. Natività altra di San Andrea, tutte poste nelle rispettive contrade della villa di Buia e vengono officiate dalli due Reverendi Vicari Curati di questa Pieve come è notorio. Buia dall'offizio 16 aprile 1791. Giuseppe Piccoli Concell:“ E la questione si trascinò di ufficio in ufficio per ben 15 mesi prima che avesse a sortire al suo atteso e naturale effetto. Riportiamo quì pertanto la sentenza che liberava Buia da Udine, e per la quale per tanti anni si aveva invano brigato: “1792, 9 maggio: Il Cons: di XL, al Criminal Giudice Delegato. Udito il consiglio Eccell. di XL al Criminal C. D. il Comun de Buia, e R. R. Vicari della Pieve di San Lorenzo di detto Luoco umilmente istante col mezzo dell'Ecc. suo avvocato il giudizio come segue. Sarà terminato e deciso che l'Eccell. Senato colli Sovrani suoi Decreti per oggetti sapientissimi di provvedimento alli suoi sudditi abolito gli abusi della Romana Curia e represtinate le Mense Parrocchiali nell'antico loro naturale Stato e diritto, non possono essi Nobb. Sigg. Pressidenti della fabbrica del Duomo e Rev. Capitolo assuntor prettendere di continuar nell'indebita esazione del Quartese proprio, e appartenente alla chiesa parrocchiale di Buia, di cui fu spogliata con Bolla 1512, essendo il quartese di quella mensa per Allora a Santo Stefano era Vicario il Rev. Giovanni Rottaro, investito da S. E. Gerolamo Gradenigo il 23 maggio del 1774, e a Madonna era Vicario il Rev, Domenico Minisini, investito dalla stessa autorità l'8 dicembre 1783. Da notarsi che l'investitura per tutti e due i Vicari era sempre nella Pieve di San Lorenzo, ed era a vita naturai durante, come si è visto in precedenza. Di quanto giubilo questa sentenza avesse riempito l'animo dei buiesi, che rivedevano la loro Pieve ritornata alla sua indipendenza, lo prova una lettera del notaio Rodolfo Barnaba, che, patrocinata la causa, si era recato fino a Venezia ad attendere l'evento, e appena conosciuto l'esito scriveva ai Vicari affrettatamente che bisognava cantare un “Tedeum in chiesa”. Ma nel 1815 essendo venuto a mancare ai vivi il Vicario Rottaro, residente presso la chiesa sacramentale di Santo Stefano, l'autorità tutoria venne nella decisione di dare alla Pieve di Buia, come nei passati secoli, un proprio Pievano, sull'esempio di ogni altro paese, Pieve e Parrocchia. E quì riportiamo testualmente il decreto, che doveva generare attriti, urti e confusione alla Pieve ed agli animi di un popolo chiuso nei confini di uno stesso comune. “Verificatosi il caso, per la morte del M. R. Don Giovanni Rottaro, uno dei Vicari della Pieve di San Lorenzo di Buia di questa Diocesi, seguita nel 26 maggio u. s. di stabilire nella Pieve medesima l'unico parroco attuale, giacchè per le accorse vicende il parroco abituale fino ad ora rappresentato da due Vicari più non sussiste, e vedendoci necessaria una nuova sistemazione circa il Parrocchiale Ministero presso quella numerosa e dispersa popolazione, dopo d'essere fatta da noi una ispezione locale per conoscere le circostanze tutte confluenti al maggior bene delle anime, udito il Vicario superstite M. R. Don Domenico Minisini, sentita la municipalità ed i fabbricieri, rilevato il sentimento della popolazione di Buia, in generale, consultato l'importante affare coi soggetti più riputati per integrità, dottrina e prudenza, e dato ad ogni cosa il più savio, e maturo riflesso, col tenore delle presenti siamo divvenuti a deliberare quanto segue: I° Dichiariamo unico Parroco della Pieve di San Lorenzo di Buia il Vicario superstite M. R. D. Domenico Minisini con tutta l'autorità, privilegi, diritti e rendite spettanti alla parrocchialità medesima, niente eccettuato, verso però gli obblighi infrascritti, che saranno comuni anco ai di lei successori. Egli ed i suoi successori Parrochi avranno la residenza presso la chiesa sacramentale di S. Stefano, come il luogo di tutti il più adattato per ogni riguardo; e sotto la sua cura immediata, oltre tutto il distretto, che prima era affidato al Vicario di S. Stefano, avrà tutte le case spettanti al Monte, sopra del quale vi è la chiesa Matrice di S. Lorenzo, e le villette, o borghi di S. Floriano, Sottocostoia e Tomba, perchè più vicini ad avere prontamente le spirituali assistenze. Al Parroco solo competerà l'ufficiatura nella chiesa Matrice di S. Lorenzo, ed a lui solo l'uso del parrocchiale sigillo egualmente che la descrizione, e custodia dei Registri di tutta la pieve“. Il resto dell'articolo primo si dilunga a descrivere le ufficiature riservate al parroco nella Matrice, e che non crediamo utile cosa riportare e passiamo pertanto al “II° Affinchè la popolazione della Pieve di Buia così numerosa e dispersa possa essere meglio assistita determiniamo che oltre il Parroco vi sia altro sacerdote Coadiutore col titolo di Vicario totalmente soggetto, e dipendente dal parroco, il quale abbia ad assistere il distretto cui fin'ora ha assistito il Vicario Minisini, meno quanto col precedente articolo è stato attribuito al Parroco, ed abbia a risiedere presso la chiesa sacramentale della B. V. Maria, ed offiziarla, salva per altro al Parroco la totale libertà di portarsi quando-cunque a funzionare anche in detta chiesa della B. V. M. come in ogni altra della Pieve. Sarà proprio del Vicario l'amministrare i SS. Sacramenti per le persone dell'attribuito distretto soltanto, predicare, istruire, assistere anche nel Cimitero della Matrice alle tumulazioni, e fare le altre funzioni solite nei giorni non eccettuati per Nel III° articolo si fissano le modalità delle rendite da assegnarsi al Vicario, le quali non dovevano essere meno di Vi è poi il IV° articolo dove E si chiude: “Le presenti note saranno comunicate in forma autentica al M. R. Minisini ora dichiarato Parroco; alla Municipalità, ed al Vicario allorchè sarà eletto per la esatta esecuzione di quanto a ciascuno rispettivamente incombe: tanto ect, così ect. Udine dall'Uffizio Capitolare S. S. nel giorno 2 8bre 1815. Mattia Capellari Cancel. Vic. Cap. S. S. Alfonso Belgrado Cancell. Cap. S. S. “ La nuova sistemazione unificava, come civilmente, anche religiosamente il Comune, e rialacciava dopo più di trecento anni la serie dei Pievani di Buia. Ma questo Vicariato di Madonna “dipendente e soggetto” cozzava contro la tradizione, l'abitudine, la circoscrizione formata attorno alle chiese, e perciò che questo “distretto” mal accettò l'unione sotto un'unico capo spirituale. E probabilmente, se il Pievano avesse avuta la sua residenza in Monte, presso la gloriosa Matrice, non si avrebbe avuto quella serie di guai, ripicchi e cavilli che durarono per ben quasi cento anni. E le prime disillusioni e amarezze di quella ideale unione spirituale, fu lo stesso primo Pievano Don Domenico Minisini a provarle. A lui seguiva il M. R. Don Tommaso Bonetti, di San Vito di Fagagna, nel 1823, che si mise a por mano alla sistemazione della Pieve, ed a conciliare le opposte correnti, derivanti dall'accennato secolare antagonismo, formato intorno alle due chiese maggiori, dopo Ma a nulla sortì: poichè ogni modifica alle funzioni, ogni decisione, derivante anche dalle superiori autorità e dal Comune stesso, che in ogni cosa aveva ingerenza, e qualche volta, aveva interesse, ad aiutare l'una o l'altra parte, furono causa e motivo di screzio. Basti accennare alla processione votiva di Comerzo, che si fa tutti gli anni il giorno seguente all'ascensione. Due furono i moventi che trascinarono gli esponenti dei due Reparti, o Distretti, a bastonarsi colle croci e a farla sospendere per due anni. Il primo motivo era quello di avere fatto un crocefisso nella Matrice, apposito per le processioni tutte della Pieve. — Ed il secondo per avere deciso, di concerto Pievano e Comunità di Buia, che la processione che cominciava ad Avilla e finiva a San Floriano, finisse a San Stefano. Lo scopo di questa modifica, era quello di tutelare al decoro degli apparamenti ed insegne, che non potendo restare nella chiesa di San Floriano, erano portati nelle singole chiese con poco rispetto. Ma procediamo per i fatti. Si era nel 1834. Alla processione di Comerzo, contro l'autorità del Pievano e della Comunità, il Crocefisso della Chiesa di Madonna, precedette tutte le insegne della Pieve, suscitando confusione e malumore. Ma al ritorno della processione, scoppiò la bomba; i più accesi delle due parti — Madonna e Santo Stefano — finirono no col bastonarsi, usando le croci come arma di offesa e difesa. In seguito a questo fatto l'autorità aprì un'inchiesta e sorti un processo. Dice la sentenza: “affine di togliere in avvenire ogni adito od innovazione ed a mal umori delle processioni che si fanno in codesta parrocchia Decreta: 1° Nelle processioni ove entra il SS. Sacramento non si farà uso in avvenire di nessun Cristo. 2° La processione della Madonna di Comerzo sarà preceduta tanto nell'andare che nel ritorno dal Cristo della Madonna, bene inteso però che immediatamente dietro ad esso seguano i confratelli del Carmine colle loro divise. 3° Quando detta processione sarà di ritorno, entrerà nella Chiesa di Avilla, dove saranno recitate le ultime orazioni, ritenuto però che dalla detta Chiesa la processione si dovrà dividere in due, vale a dire, le insegne, gli arredi sacri, i sacerdoti della Chiesa di Madonna si recheranno processionalmente per la propria strada alla chiesa rispettiva, e le residue insegne coi propri sacerdoti si recheranno processionalmente alla Chiesa di S. Stefano, nelle quali chiese sarà sciolta la santa adunanza. 4° Nelle processioni delle Rogazioni sarà sempre preceduto tanto nell'andata che nel ritorno dal Cristo della Parrocchiale di San Lorenzo, giacchè si tratta di una processione di rito proprio della parrocchia”. L'anno seguente, 8 giugno 1835, al ritorno dalla processione di Comerzo, allorquando questa doveva dividersi, secondo la ordinanza della sentenza, uno di Avilla, che non si nomina per ovvie ragioni, si parava dinanzi ai crociferi e imponeva che questi avessero proseguito per San Floriano come prima si era fatto. Di nuovo nacquero dei disordini, per cui l'autorità sospese le processioni, e solo nel 1838 si potè riprenderle, dopo altre inchieste, ordinazioni e sentenze. Il 17 maggio di quell'anno il Vescovo Emanuele Lodi, in calce alla lettera di ripristino della tradizionale processione votiva, rimandata fino a noi, aggiungeva di proprio pugno: “fa poi voti l'umilissimo Vescovo di Udine perchè la pace regni costantemente in quel circondario troppo spesso agitato e sconvolto a pretesto di zelo per le tante pratiche di religione quando forse i pochi istigatori della discordia, o non conoscono la forza di tal vocabolo, o nol rispettano.,, Così dicasi delle fraterne del Rosario nella Chiesa di S. Stefano, e quella del Carmine nella Chiesa di Madonna soppresse con ordinazione dell'Ecc. Governo il 23 Agosto 1835 n° 561, i di cui confratelli potevano iscriversi nella confraterna del SS. Sacramento, la sola permessa dalle leggi. Anche questa soppressione sollevò dei malumori, e solo una ingiunzione severa e minacciosa dalla Pretura di Gemona, valse a sopprimerle definitivamente, dopo due anni, cioè nel 1837. Morto il Bonetti nel 1864 succedeva il M. R. Pietro Venier di Gradisca di Sedegliano, che alla Pieve riusciva a dare un assesto generale, sia nelle alterne solenni funzioni che si celebravano nella Matrice, come nelle filiali, preparando un calendario Parrocchiale atto ad appagare tutte le correnti. Ai suoi figli spirituali diede un bellissimo libro di preghiere, con cenni storici sulla Pieve, sulle sue Chiese e l'orario delle annue funzioni, intitolato “Il Parrocchiano di Buia”. Ed alla Pieve si prodigò tutto, ampliandone E tutta Buia, nonostante le diatribe ed i dissapori, vi concorse alla sua erezione. Cominciati i lavori nel 1872 finirono nel 1886 fra il giubilo di tutto il popolo. In premio di tanta attività veniva nominato Monsignore. Ma non quì si ferma l'attività di Mons. Venier, che nel 1886, benchè vecchio e ammalato, dà tutto il suo appoggio a costruire la nuova Chiesa di San Stefano, aiutando così, colui che doveva succedergli nella Cura. Mons. Venier chiuse la sua laboriosa giornata il 7 giugno 1902, e si può ben dire sulla breccia, fra il compianto del suo popolo. Il M. R. Giuseppe Bulfoni di Codroipo gli successe nello stesso anno, ereditando tanta messe di esperienze, e continuando su quella strada, tracciatagli dal grande Pievano in ben 17 anni che gli fu cooperatore. Questi nei primi anni del suo Pievanato, vide effettivamente tutta Buia sotto la sua spirituale giurisdizione, con l'incorporazione alla Pieve, Decreto 30 Novembre 1905, dei borghi di Sala e Collosomano, borghi che non sappiamo come fossero stati incorporati alla Parrocchia di Vendoglio, poichè si legge che fino nel 1562 i Vicari di Buia, percepì- vano: “staia 1 di formento e staia 1 di segalla da una contrada della Villa di Buia, di case N. 5 e povere, chiamate Coleseman”. Il Bulfoni provvide a costruire una sede degna ai Pievani, con l'attuale casa canonica, che decora il centro del paese. Ed anch'egli nel 1907 venne nominato Monsignore. Di più, Mons Bulfoni vide elevata Nel E questo fu il primo taglio alla Chiesa Matrice di San Lorenzo. Fu tentato conservarle la sua funzione importante, eminentemente spirituale e tradizionale, ma la subita mutilazione, le mutate condizioni dei tempi, il ritmo accelerato della vita nostra, tutto concorse a contribuire al suo abbandono. Così nel 1927 tutte le funzioni parrocchiali che a lei erano riservate — ad eccezione delle feste della dedicazione IIIª domenica di novembre, e San Lorenzo — vennero trasportate nel Duomo di Santo Stefano, il quale per essere nel cuore civile del paese, è più comodo alle pratiche di pietà di tutti i fedeli. Ma non era finito: il 18 giugno 1930 S. E. Giuseppe Nogara Arcivescovo di Udine, erigeva la chiesa di San Pietro in Avilla, a Vicaria indipendente. Così di tutto lo splendore, fasto, giurisdizione e ricchezza di questa Pieve, oggi non resta che un ricordo. Si è dimenticato anche che San Lorenzo è il Patrono di Buia, la cui festa un giorno si solennizzava con esposizioni di bandiere, e coll'intervento alle funzioni della municipalità. San Stefano per le vicende dei tempi e del luogo ha assorbito tutte le sue attività e prerogative. E la bella e vetusta, grande e gloriosa Pieve, sta sola e negletta, quasi obliata sul suo alto e verde trono, forse destinata a rovinare, come una reggia abbandonata dal suo monarca e dai suoi sudditi immemori.
|