Emergenza di Gino Molinaro UN QUADERNO PER AFFRONTARE LA CATASTROFE | 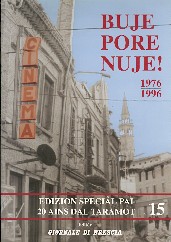 |
| INDIETRO |
Emergenza di Gino Molinaro UN QUADERNO PER AFFRONTARE LA CATASTROFE | 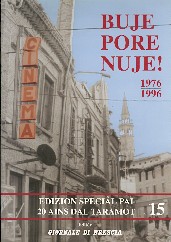 |
La voce di Gino Molinaro è stata tratta dalla registrazione di un Consiglio Comunale del 1989
| L'appuntamento fu fissato durante la notte del 6 maggio per l'indomani alle 6 presso la caserma dei carabinieri, ad Arrio. La stazione dei carabinieri era l'unico edificio pubblico agibile e dotato di mezzi di comunicazione che, in una situazione di grave emergenza quale appariva quella intorno a noi, erano di importanza fondamentale. Il radiotelefono, che funzionava grazie ad un gruppo elettrogeno, ci permise infatti di stabilire un contatto con la Prefettura di Udine, che aveva iniziato nella stessa notte il coordinamento dei soccorsi e distribuiva nei vari comuni i gruppi di primo intervento: militari, vigili del fuoco, gruppi sanitari, squadre specializzate ed autonome costituite da dipendenti provinciali, regionali e comunali e da gruppi di volontari, anch'essi indipendenti ed autonomi. Disporre di un radiotelefono significava affrontare efficacemente due problemi allo stesso tempo: uno era quello di conoscere tempestivamente l'entità dei servizi, dei materiali e dei mezzi di soccorso che stavano per raggiungere Buja, in modo da indirizzarli razionalmente ed omogeneamente verso le necessità più urgenti e gravi della popolazione, l'altro era quello di assicurare la presenza di un punto di riferimento fisso per le comunicazioni che si incrociavano tra la struttura centrale di soccorso, l'amministrazione locale e i cittadini. Ci ritrovammo quindi alle 6 del mattino presso la caserma dei carabinieri con il sindaco, Eddi Giacomini. Avevamo bisogno di uno spazio, che però non doveva interferire con l'attività della stazione dei carabinieri, così ci fu assegnato il ballatoio sulle scale esterne dell'edificio e ci furono dati un tavolino, una sedia ed un quaderno. Ho ancora impressa nitidamente questa scena con cui iniziava il mio primo giorno vissuto da amministratore di un paese distrutto dal terremoto. Sento ancora la stretta forte di un'angoscia tremenda che mi aveva accompagnato tutta la notte e che la luce del giorno aveva reso ancor più dolorosa rivelando in tutta la loro grandezza le dimensioni della catastrofe. Ricordo l'ansia e lo scoramento che provavo nel rendermi conto che la pochezza delle nostre persone e l'insufficienza dei nostri mezzi ci rendevano impotenti di fronte alla tragedia che ci aveva colpiti. Man mano che si spargeva la voce che il sindaco si trovava presso la caserma, si vedevano giungere sempre più numerosi i cittadini che chiedevano interventi e soccorso: le richieste venivano diligentemente trascritte sul quaderno, in attesa che giungessero le colonne di soccorso e che prendesse forma una struttura organizzata di pronto intervento. La gente capiva che in quel momento non eravamo in grado di dare risposte concrete alle loro richieste, ma veniva lo stesso, forse perché aveva bisogno di sapere che non era sola, che non era stata abbandonata a sé stessa. Non ho prove per dimostrare tutto questo, ma era una sensazione nitida e forte che percepivo mentre si parlava con le persone. Le pagine di quel quaderno raccolsero i nomi delle vittime del terremoto, la richiesta di notizie su gente che non si trovava, gli appelli di parenti e amici lontani che volevano sapere dei loro cari, oppure della loro casa o dell'efficienza dei soccorsi; raccolsero anche gli interrogativi di chi chiedeva se poteva venire ad aiutarci oppure semplicemente a stare accanto ai parenti ed alle case, anche se distrutte. E' stato allora che ho capito che la casa non è semplicemente un insieme di muri più o meno funzionali, solidi o esteticamente pregevoli, ma è molto di più: sassi e mattoni hanno un'anima che raccoglie la storia di ognuno di noi e quella della famiglia, quella storia che ci portiamo dentro in tutti i momenti della vita. Ecco allora che le pagine di quel quaderno non sono soltanto cronaca: sono la storia vera, sincera e non manipolata, della comunità di Buja nei suoi primi giorni di vita a contatto con una tragedia.
VOGLIA DI SOPRAVVIVERE La vita politica ed amministrativa del comune doveva riprendere ed affrontare la situazione nella pienezza dei suoi compiti istituzionali. Solo così si sarebbe ritornati a pensare ad una normalità. Fu dunque convocato il consiglio comunale, che si riunì sabato 8 maggio, alle tre del pomeriggio, in una sala messa a disposizione dalla stazione dei carabinieri. In quella seduta, come poi per molti mesi in tutte quelle del consiglio comunale, erano presenti, oltre ai consiglieri, i rappresentanti di tutte le forze che avevano il compito di affrontare l'emergenza: un funzionario della prefettura, un tenente colonnello che rappresentava l'esercito, il comandante dei vigili del fuoco, un ingegnere dell'amministrazione provinciale e ancora altri tecnici, ufficiali e volontari. Prima urgenza del consiglio comunale era quella di delineare strategie e programmi di intervento capaci di coprire secondo gravità le esigenze di tutto il territorio e di tutte le componenti della comunità. Il dibattito, incentrato su questioni così vitali, veniva però continuamente interrotto dalle scosse sismiche, finche una, più intensa delle altre, non indusse tutti ad abbandonare la sala ed a ricomporre la riunione nel cortile della caserma. I problemi non potevano attendere: dare un riparo ai senza tetto, verificare le condizioni di quanto non era crollato, demolire le strutture pericolanti che mettevano a rischio l'incolumità dei cittadini, riattivare un minimo di viabilità per la circolazione dei mezzi di soccorso, ridare alla gente un punto di riferimento attraverso la riapertura degli uffici comunali, particolarmente dell'anagrafe, su cui ricadevano crescenti richieste di certificazione, organizzare in un magazzino l'affluenza dei viveri e dei generi di prima necessità che affluivano incessantemente dalla solidarietà nazionale ed internazionale erano provvedimenti non meno importanti della rimozione delle macerie per la ricerca dei superstiti o del soccorso ai feriti. Su tutti questi problemi il consiglio comunale si misurò. Portato a termine a dispetto della paura delle scosse e della tentazione di rifugiarsi soltanto nella ricerca di soluzioni ai propri problemi individuali, riuscì a dimostrare che si potevano mettere insieme la buona volontà degli amministratori di ogni parte politica, la presenza rassicurante dei responsabili dei soccorsi e la generosità dei volontari: era quindi il primo segnale concreto di fiducia nella sopravvivenza e di speranza nella capacità di operare consapevolmente ed efficacemente per la ricostruzione e la rinascita del paese. Con l'aiuto di tecnici e dei vigili del fuoco partì subito, dunque, una ricognizione sulle strutture rimaste, e con l'aiuto dei militari partì, in Piazza del Mercato, l'installazione di una tenda per gli uffici comunali. Gli atti dell'ufficio anagrafe furono recuperati dalle macerie del municipio distrutto e, con la buona volontà dei dipendenti comunali e di alcuni volontari, fu assicurata al pubblico l'apertura ininterrotta degli uffici dalle 7 del mattino alle 10 di sera. Squadre di volontari mandati da enti, associazioni ed imprese collaboravano con i tecnici dell'Enel, della Sip e dell'acquedotto per ripristinare, con allacciamenti provvisori, la rete elettrica e di illuminazione, la rete telefonica e quei tratti di rete idrica ancora utilizzabili. Tutti lavoravano ventiquattr'ore su ventiquattro, dimenticando la stanchezza e, spesso, i bisogni della famiglia. Ricordo che in questo periodo due volontari di Aprilia venivano verso le due del mattino nella tenda dell'ufficio di segreteria, dove c'era sempre almeno un amministratore, ed offrivano del tè caldo che preparavano sul posto. Intanto si provvedeva ai senza tetto: con la requisizione di alcune autorimesse utili a sistemare i generi di sopravvivenza che giungevano in modo massiccio si organizzò la gestione dei magazzini, nominando anche la figura di un responsabile che teneva regolari contatti con le cucine delle tendopoli. Quattro primi insediamenti di tende, infatti, furono dislocati in altrettante frazioni di Buja (Collosomano e San Floreano, dove c'erano i campi sportivi adatti ad ospitarle, quindi Avilla ed Urbignacco, rispettivamente nella lottizzazione "Barnaba" ed in località "Peressini") dando ai ricoverati non solo un riparo di prima accoglienza, ma soprattutto la certezza che qualcuno si occupava di loro ed intendeva ripartire tenendo conto della loro storia, quella storia di attaccamento alle cose care che ha sempre fatto di Buja una terra di frazioni. Nello stesso periodo venivano installati l'ospedale da campo della Marina Militare, completo di sala operatoria, reparti di primo intervento e di degenza, di farmacia e di cucine, e la tendopoli di Ursinins Piccolo, che di li a poche settimane avrebbe lasciato il posto al primo nucleo di prefabbricati, denominato "Villaggio Brescia" perchè frutto degli aiuti devoluti dai cittadini bresciani al loro "Giornale". Fu anche allestito un servizio sanitario denominato "Centro operativo Sanità" che, gestito dall'allora medico condotto, dott. Ottorino Dolso con l'aiuto di volontari e alcuni dipendenti comunali assunti provvisoriamente, attivò immediatamente non solo le funzioni di medicina sociale e di primo intervento, ma anche le disinfezioni e le vaccinazioni che, insieme alle corrette istruzioni per l'uso dell'acqua, delle verdure e delle derrate deperibili, avrebbero evitato il diffondersi di epidemie tra la popolazione. La "normalità" era lontana anni luce,ma già dopo pochi giorni eravamo in grado di organizzarci per sopravvivere e per pensare a come andare avanti.
LE GRANDI SCELTE Già la decisione, approvata dal Consiglio comunale dell'8 maggio, di organizzare la prima accoglienza dei senza tetto in quattro tendopoli dislocate in altrettante frazioni, conteneva in embrione una linea di scelte alle quali Buja non poteva rinunciare facilmente: quella del rispetto di una fisionomia geografica e storica che avevano interagito per secoli. I nuclei abitati erano nati là dove la morfologia del terreno l'aveva consentito e le colline, pur omogenee nel paesaggio e percorse dalla stessa storia, avevano continuato a proteggere l'individualità dei borghi. Questa da sempre, nel bene e nel male, era stata la storia di Buja. Più che in altri paesi tra quelli colpiti, l'ipotesi di razionalizzare la ricostruzione accentrando migliaia di persone in un unico agglomerato urbano avrebbe trovato nella gente un'opposizione motivata da secoli di vita. Quando il consiglio comunale, nella riunione del 15 maggio, si trovò a discutere della scelta di un'area da destinare all'installazione di una scuola materna donata dalla regione Lombardia, il problema del futuro assetto di Buja si fece esplicito. Durante la lunga discussione, che doveva poi portare all'individuazione di Avilla come destinataria del fabbricato, le varie parti politiche sostennero con forza che "le frazioni di Buja dovevano essere ricostruite tutte, e tutte dov'erano". E' su questa linea che si collocano successivamente tutti i piccoli e grandi provvedimenti di Consiglio o di Giunta, che di volta in volta avrebbero portato alla distribuzione geografica delle tendopoli e delle baraccopoli, al potenziamento della loro organizzazione e gestione attraverso la nomina di responsabili e coordinatori, e al riconoscimento dei Comitati di Borgo, che nelle tendopoli avrebbero trovato naturale sviluppo facendo da intermediari tra la gestione comunale ed i bisogni dei singoli insediamenti. In quest'ottica di attenzione per la tutela del tessuto sociale attraverso il rispetto dell'attaccamento dei cittadini alle loro radici ed alle loro case si inquadrano poi la forte domanda, sostenuta dal Consiglio comunale fin dal mese di agosto, di costruire insediamenti di prefabbricati che contassero al massimo 130 persone, (contro la proposta regionale di raggiungere i 500 -1000 posti per ambito), e la decisione, (sempre contraria alle scelte regionali), di assegnare prefabbricati anche a singole famiglie o a piccoli gruppi di famiglie per consentire loro la ripresa o la prosecuzione delle attività agricole ed artigianali. Con gli stessi obiettivi si decisero fin da maggio, e con maggior forza dopo la replica sismica di settembre ed in piena ricostruzione, i provvedimenti con cui si dava priorità alle imprese locali nella costruzione di basamenti, impianti ed infrastrutture, allo scopo di favorire la ripresa dell'occupazione locale e scongiurare la fuga e lo smembramento della componente produttiva tra le forze sociali del paese. Infine, sempre nell'ambito delle scelte da operare in favore della conservazione delle forze produttive, si promossero o si assecondarono con la massima attenzione tutte le iniziative intese a favorire la ripresa dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio. Fu significativo, a questo proposito, l'appoggio al piano dell'Ente Regionale Sviluppo Artigianale, promosso appunto dalle forze dell'artigianato nel corso dell'estate ed approvato dal Consiglio comunale nel dicembre del `76, che individuava nell'area di Polvaries una zona a vocazione produttiva da destinare ad insediamenti provvisori e definitivi. Le imprese artigianali disastrate avrebbero potuto realizzare tali insediamenti grazie a facilitazioni opportunamente regolamentate contro il rischio di speculazioni, e comprendenti anche la possibilità di riscatto, come accadde per i lotti costruiti dalla Friulia LIS, di varia quadratura, che aziende danneggiate con necessità diverse presero in locazione. Dunque, un paese ricostruito in linea di massima negli stessi luoghi di prima, ma soprattutto con le stesse forze che l'avevano animato fino al 6 maggio era il grande traguardo da raggiungere. Ma mentre la linea del "dov'era e com'era" aveva dimostrato di poter essere seguita senza gravi contrasti sui temi generali dell'urbanistica e del rispetto delle dinamiche sociali preesistenti al sisma, la questione della ricostruzione delle scuole rivelò immediatamente l'esistenza di due schieramenti contrapposti ugualmente motivati: l'uno proponeva scelte coerenti con quella di principio generale, e voleva la costruzione di tre plessi elementari come prima del 6 maggio; l'altro, preoccupato di realizzare almeno in questa occasione i vantaggi della razionalizzazione, voleva la costruzione di un unico plesso. Il primo riconosceva con forza il ruolo culturale e sociale che un plesso scolastico può svolgere nel territorio muovendo da vicino la partecipazione delle famiglie, gli interessi degli alunni rispetto all'ambiente in cui sono fisicamente cresciuti, la risposta o la curiosità degli abitanti che osservano le iniziative di chi la scuola frequenta e rende attiva. Il secondo riconosceva con altrettanta convinzione i vantaggi economici derivanti dalla realizzazione di un unico centro, che avrebbe consentito risparmi nell'edificazione, nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella fruibilità di strutture come palestre, aule e sussidi speciali e avrebbe forse, di pari passo, stimolato un superamento di quegli aspetti tipici di campanilismo che a Buja sono il frutto negativo di un'individualità esasperata. Il Consiglio comunale del 16 luglio 76 vide dunque contrapporsi animatamente chi alla ricostruzione degli edifici scolastici dava un valore di qualità legato al rapporto socio-culturale tra la scuola ed il territorio circostante e chi vi attribuiva un valore di economia, vantaggioso per la scuola stessa e pressoché indipendente rispetto alla realtà circostante se non per un ipotetico ricompattamento di alcuni antagonismi. Forte della sua coerenza con le deliberazioni precedenti e confortata dal parere favorevole della Direzione didattica, cui si aggiungevano, anche sul piano economico motivate perplessità circa l'organizzazione dei trasporti sul vastissimo territorio comunale, la proposta del primo schieramento passò con 15 voti favorevoli, 4 contrari ed un astenuto, e dava il via al piano di ricostruzione di un edificio di scuola media e di tre edifici di scuola elementare ad Avilla, Madonna e Santo Stefano, secondo un assetto dei bacini di utenza simile a quello preesistente al sisma. La riedificazione sarebbe stata affidata all'amministrazione provinciale, che a ciò era stata delegata dalla Regione. La contrapposizione, anche negli anni a venire, lungi dall'essere superata dai fatti, sarebbe riaffiorata anche in modo strumentale ogni volta che il capitolo "scuola" si fosse ripresentato per problemi di manutenzione, di organizzazione o per la discussione di direttive estranee alle competenze comunali.
LA QUOTIDIANITA' NELL'EMERGENZA Le prime tendopoli, la premurosa assistenza dei soccorritori e dei volontari, il ritorno, benché discontinuo, di servizi come acqua, luce e viabilità davano quanto bastava alla sopravvivenza. Ma sopravvivere significa anche, e forse soprattutto, avere delle prospettive di futuro e quindi cercare ostinatamente condizioni di ritorno alla "normalità", in cui il benessere fisico possa il più possibile accompagnarsi ad un accettabile grado di equilibrio psicologico e sociale. Ci rendevamo conto che riconquistare quell'equilibrio sarebbe stato mille volte più difficile che ricostruire ad uno ad uno tutti i muri distrutti. Quel traguardo sarebbe stato tanto più raggiungibile quanto più fossimo stati capaci di attraversare l'emergenza ricostituendo, giorno dopo giorno, piccoli e grandi punti di riferimento capaci di dare sicurezza rispondendo ai nostri bisogni. Ognuno, nella sua misura e nel suo ruolo, superati i primi momenti di sconforto, si dedicava a questo, ingegnandosi con attrezzature e materiali di fortuna per recuperare non solo le cose, ma anche condizioni di vita migliore. Quando, a poche settimane di distanza dal 6 maggio, si profilò il rischio che la stanchezza e la demotivazione facessero appiattire le reazioni della gente su una passiva accettazione dei servizi e dei soccorsi del volontariato o dell'esercito, si ricorse ad ogni forma di coinvolgimento per stimolare una reazione positiva, come l'utilizzo di personale locale per far funzionare le cucine da campo per sostituire i volontari. Le istituzioni dovevano però pensare soprattutto alla sicurezza igienica, all'assistenza delle persone più esposte ai rischi di crisi fisiche o psicologiche, alla tutela della salute, alla scuola e a tutto ciò che poteva essere di incentivo alla qualità della vita. Non si contano i provvedimenti amministrativi di Consiglio o di Giunta e le conseguenti iniziative che ebbero lo scopo di rendere più accettabili le giornate nelle tendopoli con il miglioramento della loro funzionalità e dei loro servizi: dalla nomina dei responsabili per il coordinamento con l'autorità comunale alla riorganizzazione dei magazzini, dalla copertura delle cucine alla pavimentazione degli spazi comuni, dall'installazione di servizi igienici attrezzati e funzionali alla dotazione di impianti idrici, elettrici e di comunicazione fondamentali, tutto voleva concorrere a far sì che la nuova vita avesse alcuni elementi di sicurezza e comfort. Più avanti nel tempo, tutte queste attenzioni sarebbero state moltiplicate con ulteriori interventi migliorativi (asfaltatura della viabilità, costruzione di una adeguata rete fognaria, disponibilità di riscaldamento elettrico, ecc.) nelle baraccopoli, dove il tempo da trascorrere in attesa della casa sarebbe stato più lungo. Indubbiamente, tra i tanti beni perduti uno era impossibile da restituire, soprattutto nella vita in tenda: la privacy, il rispetto per l'individualità delle abitudini. La forte connotazione comunitaria della vita in tenda, accompagnata da comprensibili stati di depressione, di irritabilità, di esasperazione, si rivelò ben presto lacerante nella gestione quotidiana dei rapporti sociali. La solidarietà totale dei primi momenti di emergenza, quando tutti condividevano ogni cosa senza guardare a contrasti o rancori, lasciava il posto a crescenti stati di tensione che colpivano soprattutto i più deboli: i vecchi, che si vedevano privati del loro breve futuro e del frutto dei sacrifici di tutto il passato, i meno abbienti, che non sapevano su cosa contare per rimettere in piedi i loro muri e, naturalmente, coloro che erano stati colpiti negli affetti, in confronto ai quali tutto perdeva di significato. A tutto questo si aggiungeva la preoccupazione per le malattie fisiche, per la possibilità di contagi derivanti dal brusco cambiamento della situazione igienica, per le condizioni di sopravvivenza e di cura dei malati. Il problema salute veniva immediatamente affrontato con l'installazione dell'ospedale da campo della Marina Militare ad Arrio, con le prestazioni di medici volontari e, fin dall'8 maggio, data cui risale la delibera di assunzione di due aiutanti da affiancare all'allora medico condotto, dott. Dolso, per formare il Centro Operativo Sanitario, con una organizzazione dell'assistenza sanitaria che si sarebbe fatta via via più puntuale ed articolata ed avrebbe risposto ad esigenze di pronto intervento, di medicina sociale di base, di disinfezioni e vaccinazioni antitifiche e avrebbe affrontato tutte le complesse e vaste esigenze di informazione che riguardavano l'uso dell'acqua, delle verdure e delle derrate deperibili per evitare il diffondersi delle epidemie tra la popolazione. Il problema dell'assistenza psicologica e sociale, invece, aveva una dimensione strisciante della quale fu possibile prender atto soltanto per gradi. Si rivelò allora preziosa la presenza del volontariato religioso proveniente dalla diocesi di Firenze, gemellata con la parrocchia di Santo Stefano. L'organizzazione messa a punto dai volontari fiorentini per assistere gli anziani, i disabili, i cittadini comunque carenti di sostegno, anche psicologico, fu presa a modello dall'amministrazione comunale per avviare, con proprio personale, un servizio di assistenza domiciliare. Un medico, una assistente sanitaria, un'assistente sociale e tre domiciliari avrebbero portato avanti negli anni, prima nel prefabbricato donato dall'Associazione Industriali di Udine, poi nel poliambulatorio comunale, divenuto successivamente sede di distretto, un servizio di medicazione, pratica di iniezioni, accompagnamento dei disabili presso ospedali ed ambulatori, disbrigo di pratiche burocratiche, previdenziali ed assistenziali e di faccende domestiche: tutto, il più possibile, con il coinvolgimento delle famiglie. Al servizio di assistenza, regolato con delibera consiliare nel 78, ed a quello di medicina di base del Centro Operativo Sanitario si sarebbero aggiunti i servizi di medicina scolastica, con particolare attenzione per la cura e la prevenzione odontoiatrica e quelli di medicina materno infantile e di igiene mentale. Anche la delibera consiliare del 1978, con cui si accettava la proposta del Governo degli Stati Uniti di costruire un Centro Anziani presso la Casa di Riposo comunale, confermava che il passaggio attraverso i problemi socio-sanitari dell'emergenza era avvenuto capitalizzando risorse ed esperienze che potevano offrire opportunità anche migliori di quelle preesistenti al 6 maggio. Un altro grave problema da prendere in esame per riportare un po' di normalità nell'emergenza era quello dell'avvio dell'anno scolastico che, oltre ad affrontare nei tempi dovuti la questione della scolarizzazione obbligatoria, avrebbe ridato alle famiglie i ritmi e gli impegni consueti nell'educazione dei figli. Il volontariato della scuola, tramite l'ECA che coinvolse per iniziativa della Direzione Didattica tutti gli insegnanti disponibili, aveva organizzato fin dai primi mesi dell'estate attività di animazione, attività espressive e di socializzazione tenendo impegnati i bambini nelle tende dislocate in varie frazioni. Con l'avvicinarsi dell'autunno, tuttavia, la necessità di disporre di locali attrezzati per l'attività didattica si fece di urgenza prioritaria. Il 16 settembre, in piena replica sismica, la Giunta municipale, ottemperando alle deliberazioni del Consiglio comunale, decideva l'acquisto di un prefabbricato da affiancare a quello già donato dal Giornale di Brescia ed installato ad Ursinins Piccolo; poco dopo si aggiungeva l'acquisto di un'altra struttura provvisoria da collocare, sempre ad Ursinins, nei pressi dell'ex stazione lungo l'Osovana. Il primo gruppo di locali avrebbe ospitato, a fianco del Villaggio Brescia, le scuole elementari, che avrebbero funzionato con doppi turni fino al rientro degli alunni di Avilla e Madonna nelle loro scuole ricostruite (1978); il secondo fabbricato avrebbe ospitato la scuola media. Eseguiti i lavori di installazione, pavimentazione e finitura a ritmi serrati, l'anno scolastico partì a pieno organico l'8 novembre `76. Gli ultimi a rientrare nella loro scuola sarebbero stati, nel 1979, gli alunni di S.Stefano. Ricostruita dall'ANA con finanziamenti del Governo statunitense, la scuola prendeva il posto del vecchio imponente edificio il cui recupero era stato giudicato svantaggioso sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto funzionale. Ma questi erano ormai tempi di piena ricostruzione.
LA GRANDE SFIDA DI SETTEMBRE L'11 settembre, con la Messa e la cerimonia di ringraziamento celebrate al campo ANA di Sottocostoia, si stavano simbolicamente salutando non solo gli Alpini che avevano lavorato tutta l'estate per recuperare e consolidare fabbricati e per costruire le 33 casette che li avrebbero ricordati per sempre nel cuore dei Bujesi, ma anche tutto il grande esercito dei volontari, che ci aveva generosamente accompagnati attraverso la prima emergenza, aiutandoci a ripristinare, consolidare, proteggere, riparare fabbricati e rustici non demoliti, in modo che si potesse cominciare a pensare all'inverno ed alla ricostruzione. Fin dal 12 giugno, con il rientro dei primi gruppi di volontari organizzati, il Consiglio comunale non aveva fatto che approvare ordini del giorno esprimenti gratitudine nei confronti di chi, passo dopo passo, ci aveva sostenuto in quei mesi difficili per salutarci quando ormai il peggio sembrava passato. La scossa che sconvolse quella Messa al campo e le scosse successive del 15 settembre non furono accolte solo con dolorosa sorpresa, con terrore quasi irrazionale, con un senso di angosciosa impotenza: erano il salto verso il buio della disperazione. Tanto sacrificio, migliaia di ore di lavoro, progetti, iniziative, attese: tutto veniva nuovamente reso inutile e inconsistente e, se il terremoto di maggio aveva distrutto fisicamente cose e persone, quello di settembre le prostrava definitivamente sotto l'aspetto psicologico. Il Consiglio comunale, riunitosi d'urgenza il 13 settembre, approvava all'unanimità e al di sopra di ogni divisione politica o ideologica la richiesta di un nuovo stato di emergenza, e chiedeva un ulteriore impegno alla solidarietà nazionale. Contemporaneamente prendeva atto della nomina di un Commissario Straordinario di Governo che, nella persona dell'on. Giuseppe Zamberletti, avrebbe dovuto intervenire laddove ormai la normativa e i mezzi comunali e regionali non bastavano più. Preso atto che i senza tetto erano poco meno che raddoppiati (il censimento del 23 settembre avrebbe fornito la cifra di 3988 contro i 2093 del primo terremoto!) bisognava trovar loro un riparo, e trovarlo presto perché l'inverno era alle porte e la popolazione era allo stremo delle forze fisiche e psicologiche. La requisizione degli alloggi nelle località balneari di Grado e Lignano consentiva il ricovero di una parte della popolazione, per la quale furono anche allestiti servizi di collegamento e di assistenza sul posto, in modo da riccompattare il più possibile il gruppo degli sfollati e di assisterli anche lontano dal paese. L'esodo, tuttavia, non poteva essere una soluzione da favorire, pena la lacerazione totale e definitiva del tessuto sociale e delle forze lavoro. Una sola era la soluzione: i prefabbricati. Quattordici aree da destinare ad insediamenti abitativi provvisori erano state individuate e rese disponibili già da agosto; nello stesso mese, una previsione di acquisto di 120 prefabbricati bifamiliari e 80 quadrifamiliari da dislocare su 16-17 ettari era stata inoltrata alla Regione che, evidentemente, aveva tempi molto lunghi per passare all'esecutività. Ormai, d'altra parte, ogni piano era inadeguato ed erano paurosamente insufficienti rispetto alle regole della burocrazia i tempi che la gente poteva dedicare ad attendere. Se si fossero avviate normalmente le pratiche per progettazioni, espropri, appalti, finanziamenti ed operazioni di realizzazione, il paese non sarebbe stato in grado di sopravvivere. Nonostante che il Comune avesse immediatamente deliberato di devolvere tutte le donazioni in denaro di enti e privati in favore dell'acquisto di baracche, era chiaro che le risorse disponibili non avrebbero coperto neanche in minima parte le necessità. La richiesta di autorizzazione, inoltrata alla Regione ed al Commissario, per l'acquisto urgente di 80 alloggi che Regione e Commissario stessi avrebbero dovuto poi rimborsare, aveva lo scopo di snellire al massimo i tempi di posa in opera. I nuovi alloggi, comunque, sarebbero stati anch'essi insufficienti rispetto al secondo piano di intervento, dimensionato sul nuovo fabbisogno. La Giunta municipale, nella seduta del 16 settembre, formulò allora una proposta che mai prima aveva trovato attuazione nella normativa italiana: l'Amministrazione comunale predisponeva un piano di intervento assumendosi la responsabilità dell'acquisto, dell'infrastrutturazione e dell'installazione di tutti i prefabbricati necessari ad affrontare la seconda emergenza. In altre parole si chiedeva che fosse affidata al Comune la realizzazione del piano che sarebbe stato finanziato dal Commissario. Zamberletti ci mise alla prova dandoci trenta giorni di tempo per rendere abitabili gli 80 alloggi che il Comune aveva già acquistato. Se i tempi fossero stati rispettati, l'intera opera sarebbe stata finanziata. L'esempio dei tempi e dei modi con cui il "Giornale di Brescia" aveva realizzato il villaggio di Ursinins, inaugurato già il 12 luglio, ci fece confidare nella fattibilità della scommessa. Vincemmo la sfida lavorando giorno e notte, superando ogni tipo di difficoltà e soprattutto quelle frapposte dall'inclemenza del tempo. Nasceva così l'istituto della concessione, che sarebbe stato adottato da tutti i Comuni dell'area disastrata, regolando un rapporto diretto tra Commissariato ed ente locale. Attraverso la concessione e grazie all'impegno instancabile dell'ufficio tecnico comunale, che progettava i lavori e li seguiva fino all'abitabilità, venivano installati immediatamente dopo altri 240 prefabbricati di tipo "Pasotti" e, a pioggia, in aree infrastrutturate da privati, 100 casette tipo "Krivaja". Le case della solidarietà internazionale e quelle di tanti privati cittadini che affrontarono in proprio il problema alloggiativo completarono il quadro di un traguardo raggiunto tutti insieme. Alla fine dell'inverno tutti gli sfollati potevano rientrare. Avevamo vinto la battaglia più difficile, quella contro la disperazione. VERSO LA RICOSTRUZIONE L'idea di ricostruire nasceva probabilmente prima ancora che finisse quell'interminabile minuto della prima scossa. Quando tuttavia il disastro si rivelò in tutta la sua drammatica vastità, anche i problemi connessi con la ricostruzione rivelavano la loro complessità e la loro gravità. Come ricostruire? Con quali capacità organizzative ed operative? Con quali mezzi finanziari? Erano alcuni tra gli interrogativi che si poneva il singolo capofamiglia come l'imprenditore, il commerciante come l'amministratore pubblico. Il Consiglio comunale, come si è detto, affrontò subito il problema di massima del "come" affermando la volontà di ricostruire le frazioni "dov'erano e com'erano" e puntualizzò più volte, nelle decine e decine di dibattiti che lungo gli anni seguirono tutti i passi della ricostruzione, che se il "com'era" non poteva sempre essere inteso, per ragioni di costi, di opportunità pratiche, di tempi di intervento, come una fotocopia del preesistente in senso fisico ed esteriore, avrebbe dovuto essere inteso almeno in senso funzionale o, più ancora nella sua interiorità. Quanto alla mobilitazione degli aspetti organizzativi ed operativi, fu determinante la risposta delle forze lavoro con la loro capacità di reazione e di ripresa. Gli strumenti urbanistici ed i mezzi economici rappresentavano, tra le tante incognite, quelle da affrontare con assoluta priorità e col massimo impegno. Buja, caso raro tra i comuni dell'area disastrata, era praticamente sprovvista di Piano Regolatore Generale essendo esso stato approvato dal Consiglio comunale ma non ancora dagli organi regionali competenti. Era inoltre, ma questa era una situazione largamente diffusa, del tutto sprovvista di mezzi economici: basti pensare che i plessi scolastici di Avilla e Madonna erano da tempo ai limiti dell'agibilità ma non potevano contare su prospettive di intervento per mancanza di adeguati finanziamenti. La questione economica era dunque di dimensione enorme, soprattutto se si teneva conto dell'ampiezza delle infrastrutture che la disposizione geografica del comune richiedeva: oltre cento chilometri di strade, quaranta di fognature rappresentano indicativamente le cifre con cui dovette misurarsi la ricostruzione. La prima legge regionale, la n° 17 del giugno `76, era il primo segnale della volontà delle istituzioni sovracomunali di intervenire a supporto dell'edilizia privata, anche se soltanto per recuperare e riparare fabbricati con danni non eccessivamente gravi. Sarebbe però stato nel corso della seconda emergenza che si sarebbe definito con chiarezza l'intervento della solidarietà nazionale attraverso le leggi regionali n° 30 e 63, che avrebbero consentito sostanzialmente tutti gli interventi di riparazione e di ricostruzione, arrivando negli anni successivi a stabilire, attraverso l'articolo 8 della L.30, i recuperi di insediamenti di pregio architettonico o storico come il borgo dei Saletti, il gruppo abitato di Ontegnano e quello di Andreuzza. Una volta costituita, nel settembre del 77, la commissione comunale per l'erogazione dei contributi ai privati avrebbe continuato il suo lavoro fino a tutti gli anni `80 per esaminare le domande e le documentazioni necessarie ad accedere a quei finanziamenti che, in misura diversa da caso a caso, avrebbero consentito la riedificazione degli edifici privati. Di pari passo, dal momento in cui furono inoltrate alla Segreteria regionale straordinaria le prime richieste di finanziamento per opere pubbliche, la costruzione della rete idrica con il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, di strade, di impianti di illuminazione, di fognature e impianti sportivi avrebbe proseguito a ritmi incalzanti, aggiungendosi alla sistemazione dei cimiteri, alla costruzione del poliambulatorio e a quelle strutture che sarebbero state realizzate per altre vie, come le scuole ed il Centro Anziani, e coprendo un arco di tempo che non si poté considerare effettivamente concluso nemmeno alla data del 1988, quando, con l'inaugurazione del municipio e del centro di Santo Stefano si chiudeva simbolicamente il capitolo della ricostruzione. Sotto l'aspetto urbanistico, come si è detto, il problema più grave era quello della mancanza di un PRG esecutivo. Ciò comportava che le leggi regionali sulla ricostruzione rischiavano di rimanere inutilizzabili. La popolazione ed il Consiglio comunale premevano per avviare al più presto l'edilizia privata. È del luglio 77 l'interrogazione presentata dall'opposizione per conoscere l'attività della Commissione edilizia comunale rispetto alle domande di concessione di licenze edilizie. La risposta, che per altro soddisfece gli interroganti, evidenziava la necessità di trovare immediatamente una soluzione normativa che consentisse alla gente di partire coi lavori delle case: 95 licenze erano state rilasciate tra il 6 maggio ed il 28 ottobre, ma il numero delle domande esaminate in 36 sedute della CEC era di ben 659. La risposta al problema venne dagli stessi organismi regionali che, sollecitati a trovare una soluzione in tempi rapidi, diedero le indicazioni necessarie. Nel settembre del 77 il Consiglio comunale approvò allora, ai sensi della LR 33/76, la perimetrazione dei nuclei urbani distrutti dal terremoto, fornendo uno strumento propedeutico al PRG ed ai Piani Particolareggiati di ricostruzione, che avrebbero delimitato le borgate, o parti di esse, per la ricostruzione delle quali sarebbe stata necessaria una pianificazione dettagliata sia in ambito pubblico che privato. Approvato il 20 luglio 78, il PRG sarebbe diventato di li a poco esecutivo con l'approvazione regionale, ed avrebbe dato il via ad una ricostruzione finalmente chiara anche sotto l'aspetto della legittimità. L'approvazione, nell'agosto successivo, dei PP, frutto di un assiduo confronto dei migliori professionisti con la popolazione, perfezionava ulteriormente gli strumenti urbanistici necessari alla piena ripresa dell'edilizia privata e pubblica. A settembre il Comune, dotato di tutti gli elaborati necessari, poteva inoltrare alla Regione la richiesta di contributi per un importo di 33 miliardi, che sarebbe stato erogato l'anno successivo in base ad un programma di interventi redatto dall'Amministrazione comunale ai sensi della LR 63/77. La ricostruzione era un evento storico di portata straordinaria, ma era ormai entrato nella vita quotidiana e stava diventando realtà. LA SOLIDARIETÀ Nel pieno della prima emergenza, quando i disagi della nuova vita nelle tende e nei ripari di fortuna cominciavano a pesare soprattutto sul piano psicologico, ci fu un momento in cui sembrò che, tra la popolazione dell'area disastrata, l'impazienza di ritornare in una vera casa ed il bisogno di accelerare i tempi del ritorno dovessero trasformarsi nel rifiuto di ogni intervento esterno. "Di bessoi", ricostruire da soli, era uno slogan che enfatizzava le capacità di impegno e di lavoro della nostra gente contro tutto ciò che veniva visto come un'indebita ingerenza o come un rischio di ripetere le tristi esperienze dei terremoti che avevano colpito altre parti d'Italia negli ultimi decenni. Forse a questo atteggiamento di chiusura non era estranea nemmeno la preoccupazione creata dalla presenza, per altro del tutto fisiologica e prevedibile, di una minoranza di profittatori e di squilibrati che tentarono di agire a proprio vantaggio mimetizzandosi tra i volontari. Si trattava, però, sicuramente e soprattutto di una strumentalizzazione che, in tutta evidenza, era non solo provocatoria e presuntuosa, ma anche inconsistente sul piano pratico e lontana dalla realtà. In verità, fin dalle primissime ore dopo le 21 del 6 maggio, il lungo cammino della ricostruzione sarebbe stato percorso insieme dalla nostra gente, con il suo lavoro dignitoso ed infaticabile, e da quel grande movimento di persone, mezzi e sentimenti che è passato semplicemente sotto il nome di "solidarietà". La solidarietà assunse le dimensioni più diverse, da quella semplice del dividere la paura e qualche genere di conforto col vicino di casa a quella dei grandi finanziamenti che enti, associazioni e governi, primo tra tutti quello nazionale, erogarono in favore della ricostruzione e della rinascita. L'aspetto economico collegato alle donazioni ebbe naturalmente un peso determinante nella capacità di ripresa: basti pensare alla dimensione di talune opere come il Centro Anziani e la scuola elementare di Santo Stefano, donata dal Congresso degli Stati Uniti ed affidate alla realizzazione dell'ANA, oppure il Villaggio Industriali, realizzato ai piedi del Ponzale dall'Associazione Industriali di Udine, o al recupero di chiese, campanili ed opere d'arte, reso possibile dai gemellaggi tra parrocchie e diocesi, oppure ancora agli insediamenti abitativi della Croce Rossa svizzera e bavarese, della Caritas e della Camera di Commercio carinziane e a tutti i grandi interventi che risolsero tanti problemi delle due emergenze, per non parlare del costo dell'intera ricostruzione dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche coperto dai contributi statali cui concorsero con una tassa una tantum tutti gli Italiani. Il merito più grande della solidarietà, tuttavia, fu certamente quello di far arrivare a chi era stato colpito un conforto, un sostegno ed una partecipazione senza i quali nessuno avrebbe avuto la forza psicologica di reagire. Le centinaia di persone che, come gli Alpini, abbiamo visto alternarsi instancabilmente accanto a noi per recuperare, riparare, costruire, rinunciando al riposo ed al tempo libero, hanno lasciato il segno non solo per la quantità enorme di lavoro svolto, ma anche per la carica di ottimismo che sapevano diffondere con la loro attività e per la generosità che sapevano testimoniare con il solo fatto di essere presenti a spendere le loro forze per non aspettarsi in cambio nulla più di un grazie. Allo stesso modo, la costruzione del Villaggio Brescia, realizzata tramite una sottoscrizione del "Giornale di Brescia" tra i suoi lettori, fu importante non solo per i problemi che risolse dando fin dal mese di luglio una casa ad una decina di famiglie e ad alcune attività commerciali ed artigianali di Ursinins Piccolo ed interpretando i bisogni della comunità con la donazione di una scuola, ma anche e soprattutto perché, nei tempi in cui fu costruito, dimostrò che valeva la pena di sperare nel far presto, nel fare bene e senza costi impossibili. Fu cosi certamente un esempio prezioso per l'amministrazione comunale quando, nella seconda emergenza, i tempi ed i costi di realizzazione degli insediamenti provvisori dovettero essere contenuti ai limiti dell'impossibile. È questa indubbiamente un'altra considerazione positiva che riguarda la solidarietà: al di là della diversa capacità organizzativa e dell'efficienza dei tanti volontari che si susseguirono nel paese, fu molto spesso in grado di guidare iniziative o proporre esperienze e modelli organizzativi che altrimenti ci sarebbero state sconosciuti. Da soli, coi nostri mezzi inesistenti, in tempi in cui non esisteva alcuna struttura di protezione civile (che sarebbe stata successivamente avviata proprio dal ministro Zamberletti sulla base dell'esperienza friulana), senza l'esperienza determinante dell'esercito e di certi gruppi di volontari, non saremmo stati in grado nemmeno di recuperare i morti coperti dalle macerie, né di offrire in tempo un riparo dalle intemperie, che fin dalla prima settimana aggiunsero disagi indescrivibili ad una devastazione già totale. E ancora, senza l'esempio dei volontari fiorentini che riuscirono a cogliere il pericolo delle lacerazioni psicologiche della vita d'emergenza e ad organizzare, secondo loro modelli sperimentati, una prima forma di assistenza domiciliare che coinvolgeva le famiglie, l'esperienza socio-assistenziale locale, divenuta modello cui si ispirò la sanità nazionale in piena riforma degli anni `80, risulterebbe a tutt'oggi più povera. C'è infine una dimensione della solidarietà che si nasconde sempre tra le pieghe di ciò che si dà per scontato o che è troppo umile e quotidiano per essere preso in considerazione: è la dimensione della qualità dell'impegno personale nel proprio lavoro. Errori, disfunzioni, contrasti, limiti umani di chi operò a contatto quotidiano con la tragedia del terremoto e coi suoi problemi non possono far dimenticare la serietà e la disponibilità di persone che hanno lavorato oltre la stanchezza, oltre i bisogni della famiglia e gli orari di servizio per non perdere tempo prezioso nella ripresa della comunità: operai ed impiegati comunali, ad esempio, e, a rappresentarli tutti, il segretario comunale dott. Adelchi Costantini, la cui professionalità, dimostrata per anni alla guida degli uffici comunali, può difficilmente essere considerata soltanto come un normale servizio dovuto. Ricordare e ringraziare ad uno ad uno tutti quelli che, in qualunque modo, hanno messo a disposizione denaro, esperienza, buona volontà e soprattutto cuore per accompagnarci nella rinascita è assolutamente impossibile. Il consiglio comunale lo ha fatto decine di volte approvando ordini del giorno, conferendo encomi solenni e cittadinanze onorarie, intitolando strade o donando il sigillo del Comune in segno di stima e di riconoscenza. Le associazioni culturali, prime fra tutte la Banda cittadina, il gruppo corale "Buje" e i Balarins, lo hanno fatto tramite un instancabile pellegrinaggio attraverso l'Italia ed altri stati, portando la voce di Buja nelle loro manifestazioni e creando solide amicizie con le comunità che avevano partecipato alla nostra tragedia. Tuttavia, poiché coi riconoscimenti ufficiali, con gli incontri e con gli scambi non si è coperta che una minima parte della lista di chi avrebbe meritato molto più di un grazie, il segno della nostra riconoscenza resterà nel tempo sulla piazza di Santo Stefano, davanti al municipio e al duomo che simboleggiano la vita civile e spirituale di Buja, nel monumento di Luciano Ceschia dedicato "ai Fratelli che hanno speso la loro vita per la terra dei padri": cittadini bujesi che hanno "speso" il loro impegno ed il loro sacrificio e, insieme con loro, i tanti amici che quell'impegno e quel sacrificio hanno condiviso per rendere possibile la ricostruzione e la rinascita. |